Di certo c’è che in Italia come in tutto il mondo occidentale non esistono più, posto che siano davvero esistiti in passato, partiti di sinistra vocazionalmente determinati a cambiare il mondo. Lo stesso partito comunista italiano appariva ormai a Geymonat come un partito riformista senza vere riforme e preoccupato più che altro di farsi accettare dal mondo capitalistico americano ed europeo. Ma per il filosofo della scienza tra democrazia e capitalismo sussisteva un rapporto di totale incompatibilità per cui era necessario chiedersi come potesse essere ancora utile un partito popolare che si fosse abituato all’idea dell’insuperabilità storica del capitalismo e che si fosse limitato a cercare il modo migliore per poter convivere con esso. Non ci si poteva più limitare, pensava Geymonat, a richiamarsi alla Resistenza rievocandone e celebrandone i valori, per operare serie e reali scelte democratiche; anzi occorreva denunciare l’uso retorico, mistificante e strumentale che della Resistenza si continuava a fare da parte di tutti i politici, ivi compresi quelli comunisti, che se ne servivano come di un «espediente a cui» in particolare «i responsabili della conduzione del Paese fanno ricorso per offuscare i problemi di oggi e per non confessare la propria incapacità di risolverli seriamente» (La ragione e la politica, cit., p. 97).
Eppure, osservava Geymonat, non era possibile non vedere l’insufficienza delle libertà formali, l’aleatorietà del cosiddetto libero voto elettorale, la subordinazione di essenziali istanze della vita civile, culturale ed economica, ad anguste logiche politiche entro cui vengono troppo frequentemente mortificati e compressi sentiti aneliti popolari ed individuali di libertà reale. Tuttavia, la vita democratica italiana sarebbe stata pensata negli ultimi decenni del novecento all’insegna del conformismo più piatto e di un moderatismo generalizzato che naturalmente avrebbe molto giovato alla conservazione o perpetuazione di assetti capitalistici ed antiegualitari di potere.
 Conformismo, aridità, mancanza di creatività coinvolgevano gli stessi intellettuali italiani che «discutono, polemizzano, dissentono liberamente, ma entro ben determinati limiti e per lo più in forme puramente retoriche» (Paradossi e rivoluzioni, cit., p. 128). I dibattiti seri, appassionati, interessati non demagogicamente alle sorti della collettività sono sempre più rari e tendono a spegnersi. Però, Geymonat era cosciente del fatto che riproporre come perseguibile un’idea di rivoluzione non comportasse nulla di puramente spontaneistico, ribellistico o terroristico, ma innanzitutto e soprattutto una presa di coscienza collettiva della necessità storica di erigere un invalicabile muro civile, culturale e politico contro qualunque forma di patteggiamento e compromissione, dentro e fuori del mondo istituzionale, con gruppi criminali e mafiosi di potere e anzi con quella stessa mentalità e cultura mafiose oltremodo diffuse persino in ambiti insospettabili della vita civile e religiosa.
Conformismo, aridità, mancanza di creatività coinvolgevano gli stessi intellettuali italiani che «discutono, polemizzano, dissentono liberamente, ma entro ben determinati limiti e per lo più in forme puramente retoriche» (Paradossi e rivoluzioni, cit., p. 128). I dibattiti seri, appassionati, interessati non demagogicamente alle sorti della collettività sono sempre più rari e tendono a spegnersi. Però, Geymonat era cosciente del fatto che riproporre come perseguibile un’idea di rivoluzione non comportasse nulla di puramente spontaneistico, ribellistico o terroristico, ma innanzitutto e soprattutto una presa di coscienza collettiva della necessità storica di erigere un invalicabile muro civile, culturale e politico contro qualunque forma di patteggiamento e compromissione, dentro e fuori del mondo istituzionale, con gruppi criminali e mafiosi di potere e anzi con quella stessa mentalità e cultura mafiose oltremodo diffuse persino in ambiti insospettabili della vita civile e religiosa.
In tal senso, una qualche rivoluzione sarebbe stata necessaria e realistica ad un tempo: perché, si chiedeva Geymonat, senza «rivoluzione, in Italia, si può battere la mafia, il sistema clientelare, il potere capitalistico? …E poi, guardiamo al mondo: si possono risolvere problemi come il Medio Oriente, l’Africa, l’America Latina? Se non vediamo queste cose, altro che eurocentrismo! Rischiamo l’italocentrismo, una posizione egoistica e provinciale» (La ragione e la politica, cit., p. 90). Certo, queste e altre affermazioni geymonatiane erano ardite e perentorie e avrebbero rischiato indubbiamente di essere smentite o pesantemente controbilanciate dalle «dure repliche della storia», risultando obiettivamente difficile ipotizzare l’esistenza di accettabili condizioni di libertà, di benessere e giustizia sociale in quelle società e in quei sistemi sociali che sono scaturiti da rivoluzioni comuniste. Purtroppo mancava nella concezione politica e marxista geymonatiana la riflessione su uno dei principali assunti marxiani: che rivoluzionario e non fittiziamente democratico comincia ad essere quel socialismo che si nutre di capitalismo, pur senza farne indigestione.
Purtroppo mancava nella concezione politica e marxista geymonatiana la riflessione su uno dei principali assunti marxiani: che rivoluzionario e non fittiziamente democratico comincia ad essere quel socialismo che si nutre di capitalismo, pur senza farne indigestione.
Per quanto molte affermazioni geymonatiane sullo stesso marxismo vadano controllate e analizzate, alcuni spunti del filosofo torinese, sia pure non esenti da qualche ingenuità, rivestono forse ancora oggi una qualche inattuale attualità, come per esempio quello relativo alla seguente affermazione: l’intellettuale rivoluzionario e democratico, per non rischiare di essere “conformista”, «deve militare fuori dei partiti burocratizzati, ed eventualmente contro di essi», pur senza sottrarsi ad «un rapporto organico con le masse» che però «non richiede la mediazione dei partiti» (Paradossi e rivoluzioni, p. 129). Qui l’obiezione è soprattutto la seguente: ammesso e non concesso che possa essere utile militare unilateralmente contro i partiti, senza quindi ipotizzare un più utile rapporto di reciprocità critica, in che modo gli intellettuali, una volta autoesclusisi dalle organizzazioni politiche, dovranno organizzare un rapporto organico con le masse che, seppure non più dai partiti, vanno pur sempre organizzate da qualcuno e in un determinato modo? Sarà, in ogni caso, possibile evitare una qualche forma di burocratizzazione?
Più chiaro invece era un altro passaggio concettuale: se in una società democratica «il ruolo delle masse è decisivo» (ivi), il compito principale degli intellettuali diventa quello di trasmettere il sapere tecnico e scientifico, contro ogni “aristocraticismo culturale” e al di là del formalismo burocratico dei partiti, e di renderne quanto più possibile l’appropriazione da parte delle masse. Solo così sindacalisti, operai, studenti ed esponenti di movimenti sociali e culturali di varia natura avrebbero potuto partecipare coscientemente e responsabilmente alla costruzione di una nuova, più qualificata democrazia. Il sapere tecnico e scientifico è di certo strumento essenziale e decisivo di lotta per una democrazia profondamente rinnovata, anche se la sua virtuosa utilizzazione presuppone una capacità di difesa dalle ingiunzioni e dalle molteplici forme di asservimento che una società altamente industrializzata tende ad imporre al singolo individuo.
Era questo un discorso irto di difficoltà ma, a distanza di tanti anni dalla scomparsa di 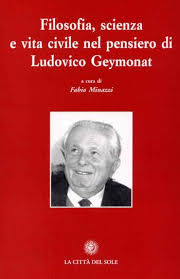 Geymonat, era opportuno ricordarlo anche come intelligente e coraggioso teorico di una democrazia non semplicemente da conservare e “conservatrice” ma profondamente trasformata e trasformatrice: di una democrazia da trasformare non sulla base di semplici istinti ribellistici e protestatari ma in virtù di una coscienza etico-politica di massa che sia capace di non confondere “il particulare” con gli onesti e legittimi interessi generali di un intero popolo.
Geymonat, era opportuno ricordarlo anche come intelligente e coraggioso teorico di una democrazia non semplicemente da conservare e “conservatrice” ma profondamente trasformata e trasformatrice: di una democrazia da trasformare non sulla base di semplici istinti ribellistici e protestatari ma in virtù di una coscienza etico-politica di massa che sia capace di non confondere “il particulare” con gli onesti e legittimi interessi generali di un intero popolo.
