di Milly Airone
Per l’uomo comune sono difficilmente comprensibili le grida manzoniane che in questi giorni segnalano la completa stasi della crescita economica italiana e lo stato di deflazione in cui versa il nostro Paese. Si dice: la deflazione in una fase di crescita economica è positiva, mentre in una fase di immobilità economica con i prezzi che calano essa è completamente negativa.
Per l’uomo comune, con o senza sviluppo, la diminuzione stabile dei prezzi è comunque desiderabile, ma i professoroni della scienza economica e soprattutto tutti i soggetti che hanno concreti interessi nell’eterogeneo ambito del mercato finanziario nazionale ed internazionale ci dicono preoccupati che, quando la produttività aumenta e i prezzi scendono, è un buon segno; viceversa, se non c’è aumento di produttività, il fatto che i prezzi tendano a scendere continuamente denota mancanza di consumo, mancata immissione e circolazione di denaro nei circuiti economici e finanziari e quindi, in definitiva, impossibilità di produrre ricchezza con un inevitabile aumento della disoccupazione e della povertà sociale e con la conseguenza di una distribuzione sempre più ridotta e diseguale della ricchezza stessa.

Perché chi vive di finanza, di profitto, di accumulo indefinito di capitale, come per esempio i burocrati europei e le oligarchie finanziarie che fanno capo alla Unione Europea, è cosí preoccupato? In fin dei conti, perché mai, anche in tempo di decrescita o di mancato sviluppo, non sarebbe possibile per una comunità nazionale vivere dignitosamente e serenamente? Perché uno Stato non asservito a determinati potentati stranieri, anche da un punto di vista monetario, non dovrebbe essere in grado di sostenere adeguatamente il suo popolo in una condizione di disagio o crisi congiunturale? Perché uno Stato ancora autonomo non potrebbe essere padrone di fare investimenti massicci per il rilancio dell’occupazione in settori strategici della vita civile e produttiva nazionale come la sanità, la scuola, la ricerca, le infrastrutture, il turismo, e quant’altro concorra certamente allo sviluppo e al progresso del benessere sociale?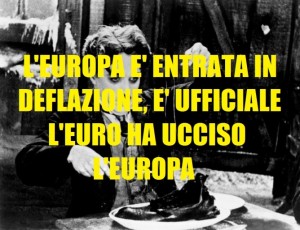
Certo, anche in tal caso lo Stato avrebbe problemi di bilancio, ma vuoi mettere i problemi di bilancio di uno Stato che non deve pagare interessi astronomici sul debito pubblico, né rispettare parametri economici imposti da altri, né essere vincolato a determinate regole commerciali e a normative giuridiche che non rispecchino specifiche necessità nazionali ma astratte e spesso discutibili necessità della comunità internazionale?
Il problema è proprio questo: che se noi non produciamo ricchezza e non tagliamo le spese sociali secondo le aspettative e gli standards europei, noi non consentiamo alle cricche finanziarie di potere che gravitano attorno alla costruzione europea di arricchirsi abbastanza, e allora ecco che queste stesse cricche, per bocca dei loro politici e dei loro burocrati di riferimento, cominciano a minacciare l’ira di Dio non senza prima raccomandare ossessivamente agli Stati e all’Italia in modo particolare la rapida attuazione delle cosiddette “riforme”: la negazione di cospicui fondi finanziari, l’imposizione di misure fiscali sempre più pesanti e indiscriminate ivi compreso un prelievo forzoso sui conti bancari, l’interruzione della erogazione di beni internazionali di prima necessità come per esempio i farmaci destinati agli ospedali, e infine un bel commissariamento volto ad espropriare una nazione, un popolo di tutte le sue principali risorse. Ecco svelato l’arcano, sia pure in termini molto divulgativi!
Ora, checché se ne dica, il problema è obiettivamente quello magistralmente colto nel XIX secolo da Marx, e cioè che «la dinamica dell’accumulazione del capitale privato comporta inevitabilmente una concentrazione sempre più forte della ricchezza e del potere in poche mani», per cui «la domanda che preoccupa è: non sarà che il mondo del 2050 o del 2100 finirà nelle mani dei trader, degli alti dirigenti e dei detentori di patrimoni rilevanti, o dei Paesi produttori di petrolio, o della Banca della Cina, o addirittura dei paradisi fiscali che faranno da copertura, in un modo o nell’altro, a tutti costoro? E secondo noi sarebbe assurdo non porla, continuando a pensare, per principio, che la crescita sia per sua natura a lungo termine “equilibrata” (T. Piketty, La democrazia deve avere il controllo sul capitale, in “Il Capitale nel XXI secolo”, Bompiani, settembre 2014).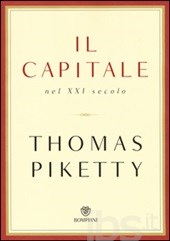
Alla luce di numerosi dati storici esaminati e di significativi raffronti statistici, osserva Piketty, «non abbiamo alcuna ragione di credere nel carattere automaticamente equilibrato della crescita. Oggi è più urgente che mai rimettere la questione delle disuguaglianze al centro dell’analisi economica e tornare a porre le domande lasciate senza adeguata risposta nel XIX secolo». Per risolvere adeguatamente i problemi dell’economia e contemporaneamente i problemi della gente, occorre buon senso prima che teoria e previsione scientifiche, occorre saggezza prima che imposizione di leggi monetarie e fiscali rigide e tassative, occorre senso di responsabilità prima che emanazione di politiche economiche presuntivamente volte a mettere i conti a posto ma realmente finalizzate a reprimere legittimi bisogni di massa allo scopo di ingrassare a dismisura già consistenti ricchezze individuali e di gruppi privati.
Renzi ha intuito che in prospettiva il benessere dell’Italia è sempre più incompatibile con la sua permanenza in Europa, anche se saggiamente lascia che questa conflittualità latente produca da sé nel tempo nella mente dei principali responsabili politici europei la convinzione che alla lunga convenga un po’ a tutti chiudere con l’UE e ritornare ad occuparsi unicamente dei problemi di casa propria. Speriamo che sia veramente questa la linea del nostro Renzi.
