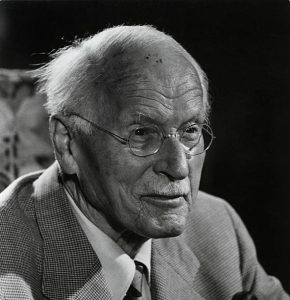«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno», dice il peccatore pentito. E Gesù gli risponde: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23, 42-43). Allora: c’è Gesù e c’è un regno, c’è un paradiso, un luogo non terreno chiamato paradiso; Gesù ne è il Signore incontrastato, Gesù ha un regno, il più potente dei regni esistiti o esistenti, e il suo regno è un regno spirituale ma è anche un regno materiale con tanto di invincibili legioni angeliche e il peccatore gli chiede di ricordarsi di lui non semplicemente quando si sarà ricongiunto con il Padre, ma quando entrerà appunto in quel regno che non potrà mai finire. Quel che non si capisce è perché certi presbiteri, certi prelati più o meno alti, certi eminenti ecclesiastici, sentono sempre più frequentemente il bisogno di dematerializzare il più possibile il regno di cui parla il Cristo e di fare del paradiso non anche un luogo con tanto di luce e scenari straordinari, di odori, di suoni, di sapori, di esaltanti esperienze conoscitive e visive, tattili, uditive, gustative, ma semplicemente un simbolo di spiritualità, sicchè alla domanda cos’è il paradiso, questi dottissimi ma infedeli interpreti della Bibbia, convinti di dare prova di purissimo e disinteressato amore per il loro Signore, finiscono per dare una risposta infallibile ma ambigua: il paradiso è stare con Cristo. Ma, spiegano, ciò significa che esso non è un luogo ma solo uno stato, una condizione spirituale. Infallibile risposta, certo, ma non molto esplicativa e soprattutto meno concreta e precisa, anzi ben più evasiva di quella inequivocabilmente emergente dai sacri testi e dalle stesse parole di Gesù che, dotato di un infinito potere spirituale, è anche fonte di un infinito potere materiale e promette non vita spirituale ma vita tout court, vita integrale, vita totale, vita in pienezza. Gesù, se è venuto a salvare la carne, i corpi degli esseri umani, evidentemente deve essere venuto a salvare anche la luce, i colori, i suoni, i sapori, i gusti, le emozioni, la sensibilità di cui quella carne e quei corpi constano e da cui, nella loro specifica realtà, essi non possono separarsi se non per non esistere come tali, ovvero come corpi sensibili ma finiti in terra e come corpi trasfigurati e immortali in cielo, ovvero come corpi gloriosi non più soggetti a peccato, malattia, dolore, morte. Dire che il paradiso consiste semplicemente nello stare con Gesù significa dire il vero a condizione che tale concetto venga implicando lo stare non solo in un generico e astratto stato di beatitudine ma anche in un luogo spiritualmente e materialmente, moralmente e sensorialmente idoneo a favorire ogni genere di beatitudine, ogni genere di effettivo e lecito godimento esistenziale. Quando Gesù, prima di morire crocifisso, afferma solennemente: «da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio» (Lc 22, 18), è evidente che allude al vino, a quell’inebriante frutto terreno e segno di allegria e di gioia conviviale, di festa, che avrebbe dovuto segnare il ritorno dell’umanità nelle braccia del Padre e l’inizio della sua vita immortale. Sarebbe potuto morire Cristo sulla croce solo per regalare all’umanità uno stato dell’anima? Ma in cosa consisterebbe questo stato dell’anima? In una semplice condizione estatico-contemplativa o in che cosa? La vita eterna, promessa da Cristo, non può essere ridotta a un semplice, ambiguo e insignificante stato dell’anima. Questo è un concetto ancora platonico, non cristiano. E’ un concetto completamente antitetico all’evento evangelico-escatologico della risurrezione dei corpi. Chi identifica il paradiso con uno stato piuttosto che con un luogo, ma si dica pure con uno stato e nient’affatto con un luogo, ancora non ha compreso che la carne è morta senza spirito ma che lo spirito è una pura e insulsa astrazione senza carne, senza sarx. Si sente dire spesso che il paradiso avrebbe un significato più esistenziale che spaziale ma esso, se non è anche un luogo, un universo, per quanto molto diverso dagli universi astronomici di nostra conoscenza, non può avere alcun significato esistenziale, perché la vita è processo vitale, è svolgimento, progresso, e tutto ciò non può aver luogo in modo puramente etereo, immaginario, simbolico, ma solo all’interno di un qualche contesto materiale, relazionale e situazionale. Viene il dubbio che quanti mettono in dubbio il paradiso come luogo, come vita attiva, dinamica, in movimento, in fondo non credano realmente nella vita del mondo che verrà, come recita il credo niceno-costantinopolitano, e, ancor meno, nella risurrezione dei morti. Che il mondo che verrà sia un mondo sovraspaziale, sovratemporale, sovrastorico, non c’è dubbio, ma questo non significa che esso sia privo di determinate dimensioni, configurazioni, leggi o assetti, che esso non abbia orizzonti, ambienti, spazi anche se completamente inediti e diversi da quelli terreni, spazi per esempio in cui i risorti abbiano la facoltà di passare attraverso i muri o le porte. Tra mondo naturale e mondo sovrannaturale sussisteranno evidentemente profonde differenze quantitative e qualitative, come si evince anche dal fatto che nel primo si muore mentre nel secondo non si può morire, ma, in entrambi i casi, si tratta di mondi, con le loro strutture, i loro processi, le loro dinamiche, la loro interna organizzazione. Se si vuol fare professione di vera fede, di realismo evangelico e non di «chiacchiera pseudo-devozionale» o «delirio mistico», bisogna essere persuasi che, rispetto a questa vita ordinaria, anche noi saremo quell’oltre rappresentato da Gesù il Salvatore, anche i nostri corpi, se Dio vorrà, «godranno della docilità che il suo corpo manifestò in vita (camminare sulle acque, comandare agli spiriti immondi) e soprattutto dopo la sua morte (sepolcro vuoto, lini piegati, apparizioni di un non-fantasma, epifanie di un non-ologramma). E’ la buona notizia, la vittoria sulla morte, che la chiesa contemporanea non ha sempre il coraggio di attestare, per timore di critiche da parte di uno scientismo supponente e per il vistoso privilegio pastorale concesso ad iniziative di carità terrena» (P. Sequeri, D, Bonazzoli, F. Manzi, E la vita del mondo che verrà, Milano, Ed. Vita e Pensiero, 2024).
Francesco di Maria
Post Views:
366