 Non c’è dubbio che, per parlare di politica economica globalizzata, occorra disporre di adeguate competenze, ma l’assenza di competenze qualificate non implica che si debba pendere dalle labbra degli “esperti” e non sia possibile assumere decisioni politiche e governative responsabili anche in difformità dalle loro diagnosi e indicazioni. Peraltro, come ormai è ben noto a tutti, sia le previsioni che le prescrizioni o le terapie degli “esperti”, dei “tecnici”, degli “scienziati dell’economia”, non di rado vengono clamorosamente smentite dai fatti che non si lasciano mai irreggimentare del tutto nelle loro sofisticate teorie. Continua a leggere
Non c’è dubbio che, per parlare di politica economica globalizzata, occorra disporre di adeguate competenze, ma l’assenza di competenze qualificate non implica che si debba pendere dalle labbra degli “esperti” e non sia possibile assumere decisioni politiche e governative responsabili anche in difformità dalle loro diagnosi e indicazioni. Peraltro, come ormai è ben noto a tutti, sia le previsioni che le prescrizioni o le terapie degli “esperti”, dei “tecnici”, degli “scienziati dell’economia”, non di rado vengono clamorosamente smentite dai fatti che non si lasciano mai irreggimentare del tutto nelle loro sofisticate teorie. Continua a leggere
L’europeismo non viene da Dio
Citazione
 I popoli europei non potevano essere unificati perché realtà storiche, linguistiche, culturali cosí diverse quali essi erano e sono non potevano non consigliare di astenersi dal procedere alla costituzione di una Unione Europea, consistendo la vera ricchezza del vecchio continente proprio nell’esistenza di una molteplicità di splendide diversità nazionali. Continua a leggere
I popoli europei non potevano essere unificati perché realtà storiche, linguistiche, culturali cosí diverse quali essi erano e sono non potevano non consigliare di astenersi dal procedere alla costituzione di una Unione Europea, consistendo la vera ricchezza del vecchio continente proprio nell’esistenza di una molteplicità di splendide diversità nazionali. Continua a leggere
Giorgio La Pira ovvero il vangelo che si fa politica
Citazione
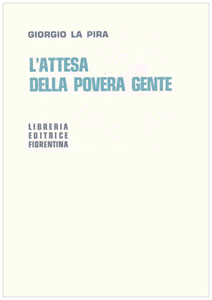 1. L’articolo 1 della Costituzione italiana, cui grandemente contribuí Giorgio La Pira, recita testualmente: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, il che significa, senza tanti giri di parole, che l’Italia sarebbe stata una repubblica ed una democrazia sin tanto che fosse venuta edificandosi e sviluppandosi sulle forze del lavoro, dell’occupazione lavorativa che costituisce la reale concretizzazione di ogni attività lavorativa, e quindi della produzione e della stessa distribuzione della ricchezza nazionale, la quale ultima beninteso avrebbe dovuto essere equamente ripartita innanzitutto tra i lavoratori-produttori dei diversi settori dell’organizzazione economica nazionale e poi in funzione di specifiche istanze assistenziali di cui uno Stato Sociale che si rispetti non avrebbe potuto non farsi carico. Continua a leggere
1. L’articolo 1 della Costituzione italiana, cui grandemente contribuí Giorgio La Pira, recita testualmente: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, il che significa, senza tanti giri di parole, che l’Italia sarebbe stata una repubblica ed una democrazia sin tanto che fosse venuta edificandosi e sviluppandosi sulle forze del lavoro, dell’occupazione lavorativa che costituisce la reale concretizzazione di ogni attività lavorativa, e quindi della produzione e della stessa distribuzione della ricchezza nazionale, la quale ultima beninteso avrebbe dovuto essere equamente ripartita innanzitutto tra i lavoratori-produttori dei diversi settori dell’organizzazione economica nazionale e poi in funzione di specifiche istanze assistenziali di cui uno Stato Sociale che si rispetti non avrebbe potuto non farsi carico. Continua a leggere
Francesco, i capitalisti e i cattocapitalisti
Citazione
 L’“esortazione apostolica” Evangelii Gaudium (La gioia del Vangelo) di papa Francesco ha scosso e innervosito i capitalisti di tutto il mondo, non solo i capitalisti non credenti o sempre sospettosi verso il cattolicesimo come il commentatore radiofonico conservatore americano Rush Limbaugh o come Jonathon Moseley, esponente del Tea Party, il movimento politico americano che difende il libero mercato da posizioni liberalconservatrici, nonché giornali di orientamento liberista come il Washington Continua a leggere
L’“esortazione apostolica” Evangelii Gaudium (La gioia del Vangelo) di papa Francesco ha scosso e innervosito i capitalisti di tutto il mondo, non solo i capitalisti non credenti o sempre sospettosi verso il cattolicesimo come il commentatore radiofonico conservatore americano Rush Limbaugh o come Jonathon Moseley, esponente del Tea Party, il movimento politico americano che difende il libero mercato da posizioni liberalconservatrici, nonché giornali di orientamento liberista come il Washington Continua a leggere
La barbarie laicista francese
Citazione
Con una lettera accorata, alla vigilia dell’incontro tra Francesco e il presidente Hollande, i cattolici francesi hanno confidato al Papa la loro “tremenda inquietudine” derivante dalle politiche anticristiane caparbiamente perseguite dal governo socialista francese: dall’imposizione del matrimonio omosessuale all’educazione al gender (per cui l’identità di genere dovrebbe sostituire la tradizionale identità sessuale) nelle scuole e alla fecondazione artificiale (con seme anche altro da quello del lui della coppia) o all’eutanasia. Continua a leggere
Enrico Letta: un politico cattolico?
Citazione
 Il mondo è oggi attraversato da una corrente di pensiero che pare essersi affermata negli ultimi tempi come posizione egemonica tra quelle espresse dalla cultura contemporanea. Tale corrente è nota come “mondialismo”, anche se occorre subito precisare che altro è il mondialismo élitario e tendenzialmente “pagano” di cui parlava David Rockefeller altro è invece il mondialismo comunitario e cristiano di cui hanno parlato anche pontefici quali Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Che poi, in ambito ecclesiastico ed ecclesiale, ricorrano spesso posizioni non inequivocabilmente riconducibili all’una o all’altra forma di “mondialismo”, è altrettanto vero e costituisce un problema grave e preoccupante all’interno della stessa comunità cattolica. Continua a leggere
Il mondo è oggi attraversato da una corrente di pensiero che pare essersi affermata negli ultimi tempi come posizione egemonica tra quelle espresse dalla cultura contemporanea. Tale corrente è nota come “mondialismo”, anche se occorre subito precisare che altro è il mondialismo élitario e tendenzialmente “pagano” di cui parlava David Rockefeller altro è invece il mondialismo comunitario e cristiano di cui hanno parlato anche pontefici quali Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Che poi, in ambito ecclesiastico ed ecclesiale, ricorrano spesso posizioni non inequivocabilmente riconducibili all’una o all’altra forma di “mondialismo”, è altrettanto vero e costituisce un problema grave e preoccupante all’interno della stessa comunità cattolica. Continua a leggere
Giuseppe Dossetti senza eredi
Adesso si è trovato anche il modo di ipotizzare che due cattolici dichiarati come Matteo Renzi ed Enrico Letta, ognuno naturalmente con la sua particolare sensibilità, possano essere in qualche modo eredi del pensiero politico di Giuseppe Dossetti. Infatti essi, per rivitalizzare la spenta e spaesata politica italiana, pensa qualcuno, potrebbero sforzarsi di rilanciare «una inattesa centralità della cultura politica dossettiana» (G. Marengo, La sinistra italiana oggi e le radici dossettiane, in Zenit del 16 dicembre 2013).
E, sebbene i due leaders del PD non si siano mai esplicitamente richiamati a Dossetti, i fautori cattolici di questa tesi ritengono che essi potrebbero fare cosa veramente utile all’Italia se, in un momento cosí drammatico e per certi aspetti simile alla situazione in cui si era venuto a trovare il nostro Paese nel secondo dopoguerra, tentassero di riappropriarsi, sia pure in una versione aggiornata, di alcuni elementi peculiari del pensiero politico di Giuseppe Dossetti: il riconoscimento di un marcato primato alla politica rispetto all’economia e a qualsiasi altro settore della nostra vita nazionale; il radicamento di tale primato «in una forte identità cristiana ed ecclesiale» com’era quella evocata da Paolo VI quando definiva la politica come una delle più alte forme della carità; la difesa ad oltranza dei princípi fondativi della Carta Costituzionale; il partito concepito non tanto come organo di mediazione tra le sue componenti interne e nei confronti di altre forze politiche costituzionali e parlamentari quanto come gruppo politico profondamente riformatore e riformatore in direzione degli eterni valori comunitari indicati dal vangelo; la potenziale funzione egemonica che lo stesso partito cattolico avrebbe dovuto esercitare ad alti livelli di progettualità economico-sociale nel quadro della dialettica intercorrente tra le diverse forze politico-culturali italiane.
Peraltro, in particolare sulla forma-partito, Dossetti, pur collaborando lealmente con De Gasperi per più di un lustro, avrebbe espresso una concezione diversa da quella del politico trentino. La DC, infatti, per il primo non doveva essere, come pensava il secondo, una specie di contenitore di istanze ed interessi molteplici ma anche virtualmente eterogenei o conflittuali, perché questo l’avrebbe condannata a sottostare a troppe mediazioni interne che alla lunga ne avrebbero quanto meno depotenziato l’originaria carica profondamente riformatrice, e allo stesso tempo non doveva puntare su una politica di compromesso con gli altri gruppi parlamentari dell’arco costituzionale solo per dar luogo a coalizioni governative stabili e durature che però ne avrebbero frenato o impedito lo spirito e lo slancio evangelicamente innovativi.
La visione politica dossettiana del partito come dello Stato non coincideva con una difesa dello status quo o di posizioni conservatrici (come forse in parte si può dire per De Gasperi), ma con una strategia democratica d’attacco volta a porre, nel nome e nel segno della fede in Cristo, vere condizioni di emancipazione non solo economica e sociale ma anche morale e spirituale, non coincidenti con bruschi e repentini passaggi “rivoluzionari”, in un Paese povero e disgregato di cui certo andava ricostruito e potenziato il tessuto sociale e le strutture economiche ma di cui andava ancor più rafforzato lo spirito di mutua solidarietà per evitare che lo stesso sviluppo economico favorisse interessi privati di tipo particolaristico e non un bene comune fondato sulla giustizia sociale e su un diritto equamente ridistributivo.
Come ha ben ricordato il 9 febbraio 2013 sul suo blog (Il lavoro nel pensiero di Giuseppe Dossetti) Pierluigi Castagnetti, che avrebbe conosciuto meglio Dossetti attraverso il personale rapporto di amicizia instaurato con suo fratello Ermanno Dossetti, non si deve dimenticare che il giurista e politico cattolico avrebbe molto contribuito a definire la struttura personalistica della Carta Costituzionale negli articoli 2 (sui diritti inviolabili dell’uomo) e 3 (sulla pari dignità sociale e sull’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge) e che sarebbe stato relatore degli articoli 7 (relativo ai rapporti tra Stato e Chiesa di rispettiva indipendenza e sovranità) e 11 (relativo al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali). Inoltre, forse ancor oggi non tutti sanno che il politico democristiano avrebbe dato, d’intesa con il comunista Palmiro Togliatti, un grandissimo apporto alla definizione dei contenuti economico-sociali della Costituzione, in particolare sul delicatissimo tema del lavoro (che già nel 1° articolo figura come vera e propria struttura portante della Costituzione).
Per Dossetti il lavoro non aveva solo un significato politico e sociale (che poteva riassumersi nel riferimento ai diritti soggettivi e agli stessi soggetti che l’avrebbero esercitato ovvero ai lavoratori), come per Togliatti, ma un ancor più irriducibile significato religioso, nel senso che il lavoro in sé per lui, indipendentemente da specifici destinatari storici, era un valore e un valore dunque non ideologizzabile, nel senso che attraverso il lavoro l’uomo è chiamato a completare la creazione di Dio e a realizzare se stesso cioè a sviluppare e dare forma compiuta all’umanità che porta in se stesso.
Quindi il lavoro veniva pensato non solo come tramite di diritti soggettivi, di rivendicazioni sociali e politiche, ma come mezzo irrinunciabile per diventare persona, per acquisire dignità personale, per estrinsecare la propria libertà-responsabilità di cooperare al perseguimento del bene comune, e implicante conseguentemente, come recita l’art. 36 formulato congiuntamente da Dossetti e Togliatti, il salario come suo frutto e anche come condizione del fatto che esso realizzasse precise finalità sociali, tra cui Dossetti includeva significativamente (per sottolineare che tutte le forme di lavoro avessero pari dignità) anche quelle proprie di tutte le attività contemplative come lo studio in genere, la creazione poetica o artistica, l’osservazione del cosmo e dei processi naturali, sino alla stessa esperienza monastica, benché poi egli non pretendesse che questa sua specifica esigenza fosse specificata nel testo.
Ecco perché e in che senso, esattamente, l’Italia doveva essere una repubblica democratica fondata sul lavoro: l’Italia per essere di tutti e per tutti, sia pure nelle forme e nei limiti esercitati dalla stessa Costituzione, doveva essere fondata costitutivamente sul lavoro, che in tal modo, e indipendentemente da specifiche congiunture economico-finanziarie, non era solo un diritto costituzionalmente garantito ma il diritto che doveva garantire la natura e la funzione democratica della stessa Carta costituzionale, con la conseguenza che il lavoro, sia come valore in sé sia come concreta opportunità di esplicazione della propria dignità personale, dovesse essere sempre e comunque tutelato dall’ordinamento repubblicano oltre che dalla e nella stessa comunità nazionale.
Certo, la centralità della persona, l’uguaglianza, la libertà, l’autodeterminazione delle comunità locali che è alla base del regionalismo e del federalismo, erano anch’essi princípi ispiratori della Costituzione ma la loro affermazione formale poteva tramutarsi in concreta e materiale attualità democratica solo alla luce del lavoro, per mezzo del lavoro e in conseguenza di un esercizio aprioristicamente garantito del lavoro. Senza lavoro non poteva esserci né repubblica, né democrazia, né produzione di ricchezza, né sviluppo o crescita che dir si voglia. Compito imprescindibile e prioritario della politica nazionale, nella sua triplice articolazione di attività governativa, attività parlamentare e attività partitica o associativa, avrebbe dovuto essere, al di sopra di ogni altro interesse o necessità di Stato, quello di tutelare sempre e comunque il lavoro, difendendolo sia dalle cicliche crisi economiche, sia da eventuali turbolenze legate alla dinamica dei rapporti internazionali tra gli Stati e a quella di possibili e specifiche controversie commerciali.
Lungo queste direttrici valoriali e politico-programmatiche veniva profilandosi il grande riformismo cristiano di Dossetti, un riformismo aperto peraltro anche all’apporto di tutte quelle forze politiche che avrebbero manifestato la volontà di concorrere non tanto alla formazione di governi stabili e quanto più possibili unitari quanto alla formazione di governi capaci di adottare decisioni serie e responsabili ai fini di una vita economica nazionale regolamentata da inderogabili princípi di giustizia sociale e da criteri non arbitrari di distribuzione o ridistribuzione della ricchezza prodotta.
Ma la DC, per Dossetti, prima e più che a possibili alleanze governative di cui De Gasperi era fautore non solo per rendere più coesa ed efficace l’attività di governo ma anche per essere personalmente meno condizionato dal proprio partito e dalla complicata costellazione di interessi che vi gravitava intorno, doveva pensare a qualificare la sua azione politica con proposte legislative e misure economiche realmente compatibili con i suoi valori spirituali e religiosi. Ora, appare del tutto evidente che né Enrico Letta, propenso più ad assoggettarsi alla volontà dei mercati finanziari e dei grandi istituti bancari internazionali che non alla volontà di Dio, né lo stesso Renzi, impegnato a fare del problema generazionale piuttosto che di quello relativo ad un allargamento sociale dello Stato il problema centrale di una “nuova” politica nazionale, potranno mai ereditare, né direttamente né indirettamente, un patrimonio politico altamente ispirato come quello di Dossetti.
Chi assume i processi economici non come materia che la politica deve plasmare e su cui la politica deve incidere in funzione dei legittimi interessi popolari ma come un prius immodificabile di cui la politica deve solo seguire l’andamento e a cui essa può semplicemente adeguare le sue decisioni sia pure con metodologie più o meno efficaci e più o meno vantaggiose, non può poi assegnare alcun primato alla politica, costretta ad essere invece una funzione ancillare dell’economia, né tanto meno per via del suo spregiudicato pragmatismo modernizzatore sarà portato a radicare la sua azione politica in valori evangelici e cristiani o si sentirà particolarmente interessato a difendere oltranzisticamente gli stessi princípi e valori fondativi della Carta ove dovessero apparire d’intralcio alla suprema logica del profitto a tutti i costi e di uno sviluppo nazionale affidato a potenze economiche straniere e quindi ormai privo di spirito patriottico, cosí come e di conseguenza non potrà guardare al partito che come ad un semplice organo di mediazione tra le diverse anime in esso presenti e rispetto ad altre posizioni parlamentari e governative piuttosto che come ad un soggetto politico autonomo e capace di interpretare i bisogni oggettivi del popolo, facendosene carico attivamente con strategie e comportamenti politici altamente e cristianamente riformistici e non con transazioni o patteggiamenti di tipo meramente demagogico ed opportunistico.
Sulla scena politica attuale, pertanto, possibili eredi di Dossetti non se ne vedono, fermo restando che, il giorno in cui una forza politica di ispirazione cristiana dovesse venire realmente assumendo un profilo dossettiano, verrebbe effettivamente introducendosi nella vita politica italiana una fortissima istanza dialettica in grado di neutralizzare da una parte la carica meramente ribellistica di tanta cosiddetta “antipolitica” comprensibilmente presente nel nostro Paese e di sottrarre dall’altra la politica stessa alle sia pur qualificate competenze accademiche e manageriali dei cosiddetti “tecnici” oppure alla gestione di “governi tecnici” anche se “politici” e stoltamente convinti che la politica possa essere usata come una tecnica “neutrale” e non già come una tecnica che produce o non produce risultati economicamente e socialmente rilevanti a seconda degli obiettivi rispetto ai quali viene resa funzionale.
Non c’è tuttavia bisogno di spiegare come e perché non ci si possa più augurare che Dossetti, come qualcuno parrebbe invece auspicare con toni quasi trionfalistici, diventi nuovamente «il principale punto di riferimento di Romano Prodi e di tutti i leader del centrosinistra» (P. Mieli, La rivincita postuma delle idee di Dossetti, in “Corriere della Sera” dell’8 dicembre 2013). La sua preziosa eredità, considerando la pochezza spirituale dei soggetti evocati, verrebbe ad essere non solo impoverita ma letteralmente dissipata, per il semplice fatto che, rispetto ai Prodi e ai vari leaders più o meno occasionali del centrosinistra, Dossetti, dotato di una ben diversa struttura intellettuale e morale, non fu un “moderato”, né fece calcoli elettoralistici né cercò mai il consenso popolare su programmi politici solo illusoriamente avanzati ma sostanzialmente subordinati ad oscure e ambigue direttive sovranazionali.
In questo caso penso si possa condividere il giudizio dato da Rosy Bindi: «il segreto di questa persona cosí straordinaria sta nel legare la dimensione spirituale (la radicalità della sua fede) e la capacità di leggere ed intervenire nella storia con la forza del cambiamento che la politica deve avere. Lasciò la politica non solo per il disaccordo con De Gasperi ma per la consapevolezza di vedere la crisi morale dell’occidente molto prima di quanto la vedessimo noi e perché intuí che la politica non era in grado di tornare all’autenticità della fede e dei valori per risolvere le difficoltà» (Intervento alla “Festa democratica del PD, Reggio Emilia 25 agosto- 9 settembre 2012” sul tema A 100 anni dalla nascita di Giuseppe Dossetti. Il ricordo di Rosy Bindi, Pierluigi Castagnetti, Alberto Melloni, Sergio Cofferati). Un profeta della politica, un profeta tout court : questo fu principalmente Giuseppe Dossetti. Questo è ciò che manca ancora all’odierno scenario politico italiano e in particolare a tutti quei cattolici che si sentono decisamente orfani della sua eredità. Almeno per ora.
Per uscire cristianamente dall’euro
 Al dualismo economico tra nord e sud del mondo e a quello tra nord e sud d’Italia sembra essersi stabilmente aggiunto oggi il dualismo economico tra nord e sud d’Europa ovvero tra i paesi centrali e i paesi periferici dell’Unione Europea, per cui, secondo alcuni analisti, nel corso del prossimo decennio questi ultimi «potrebbero essere ridotti al rango di fornitori di manodopera a buon mercato o, al più, di meri azionisti di minoranza di capitali la cui testa pensante tenderà sempre più spesso a situarsi al centro del continente» (E. Brancaccio, Uscire dall’euro: c’è modo e modo, “Alternative per il socialismo”, n. 27, luglio-agosto 2013). Non c’è infatti dubbio che il tentativo di salvare la moneta unica a colpi di deflazione salariale, a colpi di continua riduzione dei redditi individuali, degli stipendi, dei salari e delle pensioni, messo in atto nei paesi periferici dell’Unione, sembra essere destinato al fallimento, per cui appare probabile che prima o poi, contrariamente alle previsioni o agli auspici di tanti europeisti convinti, l’eurozona possa deflagrare e i paesi che ne fanno parte debbano prepararsi a sganciarsi dalla moneta unica per tornare alle monete nazionali.
Al dualismo economico tra nord e sud del mondo e a quello tra nord e sud d’Italia sembra essersi stabilmente aggiunto oggi il dualismo economico tra nord e sud d’Europa ovvero tra i paesi centrali e i paesi periferici dell’Unione Europea, per cui, secondo alcuni analisti, nel corso del prossimo decennio questi ultimi «potrebbero essere ridotti al rango di fornitori di manodopera a buon mercato o, al più, di meri azionisti di minoranza di capitali la cui testa pensante tenderà sempre più spesso a situarsi al centro del continente» (E. Brancaccio, Uscire dall’euro: c’è modo e modo, “Alternative per il socialismo”, n. 27, luglio-agosto 2013). Non c’è infatti dubbio che il tentativo di salvare la moneta unica a colpi di deflazione salariale, a colpi di continua riduzione dei redditi individuali, degli stipendi, dei salari e delle pensioni, messo in atto nei paesi periferici dell’Unione, sembra essere destinato al fallimento, per cui appare probabile che prima o poi, contrariamente alle previsioni o agli auspici di tanti europeisti convinti, l’eurozona possa deflagrare e i paesi che ne fanno parte debbano prepararsi a sganciarsi dalla moneta unica per tornare alle monete nazionali.
Sarebbe perciò il caso che anche l’Italia, anziché attardarsi in una difesa ad oltranza della sua prospettiva e della sua politica europeiste, cominciasse ad elaborare una sua precisa “strategia d’uscita” dall’euro, per non trovarsi impreparata, nel caso in cui l’eventualità qui ipotizzata dovesse materializzarsi in un breve volgere di tempo, ad adottare soluzioni capaci di favorire il ritorno quanto più incruento possibile alla lira e quindi quanto meno possibile dannoso sui diversi gruppi sociali. Non c’è, in effetti, solo un modo di gestire un’eventuale uscita dalla moneta europea: anche nel caso in cui non la si potesse scongiurare si darebbero modi “di destra” e modi di “sinistra” per governare il relativo processo di transizione, benché tale processo al momento, è sempre opportuno precisare, non sia affatto scontato sia per la forte contrapposizione tra i diversi interessi finanziari nazionali sia perché a nessuno è veramente chiaro se un passaggio del genere potrebbe essere più conveniente rispetto alla situazione attuale e a quali paesi in particolare potrebbe convenire di più.
E’ tuttavia certo che, se le cose dovessero continuare a peggiorare (e non è detto che, almeno in questo caso, al peggio non ci sia mai fine), «la scelta di uscire dall’euro e di svalutare diventerebbe l’ultima carta per tentare di rimettere in equilibrio le bilance verso l’estero dei paesi periferici» (ivi). In questo senso, purtroppo, in Italia non esiste una “sinistra” che abbia pensato e stia pensando al modo in cui eventualmente sia più opportuno gestire la transizione, anche perché, al contrario, essa continua a ripetere stancamente e fatalisticamente (chissà poi perché) che all’Europa monetaria non c’è alcuna alternativa.
Pur non sussistendo alcun dubbio circa il fatto che la permanenza della moneta unica e dello stesso mercato unico europeo dipende esclusivamente dalla partita in atto tra i diversi assetti proprietari del capitale europeo e che rispetto a tale partita il mondo del lavoro con le sue residue rappresentanze partitiche e sindacali è ormai ininfluente perché subalterno al capitalismo finanziario europeo come sinora non era mai successo, e pur essendo totalmente evidente che tale partita continua a svilupparsi in un vuoto assoluto di proposte concrete e di decisioni operative, come potrebbe essere quella di avviare programmi di investimento pubblico nelle aree maggiormente in crisi tra cui anche l’Italia, la sinistra italiana continua a non capire o fa finta di non capire che in questo modo l’Unione monetaria finirà ineluttabilmente per mostrarsi insostenibile e si attarda a discutere di debito pubblico e di PIL negli stessi termini dogmatici di sempre, come se fosse tabù discutere di questi argomenti in modi diversi da quelli stereotipati, astratti e vessatori in cui amano trattarne i centri finanziari e burocratici di potere della UE: un po’ perché certe vecchie categorie economico-finanziarie riflettono gli odierni rapporti di forza o di potere tra i diversi gruppi capitalistici europei, e un po’ per non rischiare di indebolire oltre il “politicamente corretto” gli interessi nazionalistici di alcuni forti paesi del centro-nord d’Europa.
E’ sconfortante, ma in uno scenario obiettivamente cosí fosco e cosí poco promettente o appetibile, le sinistre europee non hanno ancora neppure avviato una riflessione su come eventualmente uscire dall’euro e su come uscirne principalmente per tutelare «gli interessi del lavoro subordinato», in un momento storico in cui persino un intellettuale spento come Prodi, che è uno dei responsabili di questa disgraziata situazione europea, e sia pure mosso da ragioni opportunistiche, sembra avvedersi del fatto che non si sia ancora pensato in Europa di cambiare il Trattato di Maastricht solo perché lo status quo va bene alla Germania. In realtà, egli dice, «non è stupido che ci siano i parametri come punto di riferimento. È stupido che si lascino immutati per 20 anni. Il 3% di deficit/Pil ha senso in certi momenti, in altri sarebbe giusto lo zero, in altri il 4 o il 5%. Un accordo presuppone una politica che lo gestisca e la politica non si fa con le tabelline» (Prodi: bisogna cambiare i Trattati di Maastricht. I conti non si mettono a posto senza il Pil, in “Il Sole 24Ore” del 4 novembre 2013).
Come uscire dall’euro è dunque una questione di decisiva importanza, perché, nel caso di un’uscita forzata o pilotata, il vero dilemma non sarebbe quello tra un ipotetico sistema di cambio irrevocabile e un’ipotetica libera fluttuazione delle monete, quasi si potesse ridurre il complessivo discorso politico ad una scelta di regime valutario, essendo invece la questione, specialmente in relazione ai rapporti sociali di produzione, molto più complessa. Non è possibile eludere determinate domande e giungere impreparati al tanto temuto evento: sganciamento dall’euro e conseguente svalutazione monetaria potrebbero determinare una caduta cosí pesante del valore dei capitali nazionali (e anche questo sarebbe un tema tutto da chiarire perché al riguardo non esistono certezze o dati incontrovertibili) da imporre alle autorità governative la scelta tra il favorire l’importazione estera a basso costo e il contrastarla: da un punto di vista strettamente economico- commerciale la prima soluzione sarebbe forse (ma con molti interrogativi) la più vantaggiosa e potrebbe essere definita “di destra”, mentre da un punto di vista economico-sociale, e quindi per ciò che riguarda la produttività interna e quindi il tenore di vita delle classi lavoratrici, contrastare l’importazione e tornare ad esportare a prezzi competitivi potrebbe essere la più saggia e opportuna, anche se tale opzione comporterebbe non solo la rinuncia alla moneta unica ma anche, in antitesi alle posizioni degli stessi “liberoscambisti di sinistra”, al mercato unico europeo, il che ovviamente non sarebbe per nulla semplice da attuare.
In economia, come sta a dimostrare il complessivo fallimento delle previsioni economiche dell’ultimo lustro, non si può mai prevedere esattamente come vadano le cose: ci sono troppe variabili che, anche volendo, non potrebbero mai essere contemplate in modo preciso o adeguato.
Tuttavia, c’è un punto dell’analisi di Emiliano Brancaccio che anche i cattolici possono ritenere di poter sottoscrivere con relativa tranquillità. Questo punto è quello in cui egli afferma quanto segue: «Cosí come è da ritenersi risibile l’idea, molto diffusa a sinistra, secondo cui l’abbandono dell’euro comporterebbe inesorabilmente una svalutazione di tale portata da generare un crollo verticale dei salari reali, cosí pure risulta infondata la tesi di chi esclude l’eventualità di un impatto negativo sui salari e sulla distribuzione del reddito. Un elemento certo tuttavia sussiste: l’uscita da un regime di cambio fisso può avere un impatto negativo o meno sul potere d’acquisto dei lavoratori e sulla distribuzione del reddito nazionale a seconda che esistano meccanismi istituzionali – scala mobile, contratti nazionali, prezzi amministrati, ecc. – in grado di agganciare i salari alla dinamica dei prezzi e della produttività. Escludere tali meccanismi implica, in buona sostanza, un’uscita dall’euro “da destra”.Contemplarli significa predisporre un’uscita “da sinistra”» (ivi).
Non ci sono prove di nessun genere che con l’Europa unita economicamente e burocraticamente, con l’euro, con la BCE, con la troika, con l’ulteriore supporto dello stesso Fondo Monetario Internazionale, nelle loro forme attuali, i popoli europei nel loro insieme abbiano ricevuto o potranno ricevere dei veri benefici, mentre appare innegabile che il fronte europeo è oggi molto più diviso da interessi e programmi monetari e fiscali di quanto non fosse sino a prima della costituzione della stessa UE.
E, in ogni caso, questo è certamente vero già ora per nazioni come la Grecia, Cipro, il Portogallo, la Spagna, l’Italia o la stessa Francia, cioè per porzioni cosí consistenti d’Europa che voler continuare a parlare d’Europa e di questa Europa a tutti i costi come dell’unica possibile sarebbe come voler scommettere non sulla rinascita ma sull’ineluttabile e tragico declino della stessa Europa oltre che delle singole entità statuali nazionali.
Almeno i cattolici non possono consentirlo e non possono stare ancora ad ascoltare gli ottimistici ma irrealistici e propagandistici discorsi politici di strani cattolici come Enrico Letta che continua a ritenere di poter meglio difendere i poveri difendendo i ricchi e che non potrà esorcizzare il fallimento della sua esperienza governativa semplicemente definendo indistintamente “populisti” tutti coloro che avversano un’Europa costruita ad immagine e somiglianza di ricche e potenti plutocrazie internazionali.
Ma i cattolici, per contribuire a portare i loro paesi oltre l’Europa e l’euro dei mille inganni, non dovranno né cedere a tentazioni “complottistiche”, secondo le quali gli occulti “nemici” dei popoli debbano essere subito attaccati frontalmente e magari per mezzo di violente rivolte popolari o di atti politici inconsulti piuttosto che attraverso pacifiche ma risolute manifestazioni di dissenso e attraverso sagge ma avanzate politiche di mediazione con le autorità europee rispetto alle ciniche e fallimentari direttive sovranazionali che si vorrebbe continuare ad imporre, né fare promesse esorbitanti e strumentali come sono forse quelle che sta facendo in America in questo momento l’italo-americano Bill de Blasio.
Essi saranno credibili solo se, mentre si impegneranno a persuadere i partners europei e i massimi organismi decisionali della finanza internazionale circa la necessità di ridiscutere trattati economici e fiscali già stipulati e di ridefinire in un senso di maggiore ragionevolezza ed equità i termini e le cifre dei “debiti sovrani” (e maggiore ragionevolezza ed equità converrebbero anche alla potente locomotiva economica della Germania merkeliana che potrebbe avere a sua volta problemi molto seri il giorno in cui tutti i suoi mercati di sbocco nel sud d’Europa dovessero crollare verticalmente), saranno poi in grado di ottenere una di queste due cose: o rilanciare un’idea europeista a livelli finalmente apprezzabili dal punto di vista etico e politico con ricadute economiche altrettanto efficaci o almeno non deprimenti per tutti gli Stati membri, o l’abbandono della prospettiva europeista e la riconquista della sovranità monetaria nazionale al fine di poter più dignitosamente tutelare i legittimi interessi nazionali con una spinta, maggiore di quella resa possibile oggi dagli odierni e spesso incomprensibili “vincoli” europei, a valorizzare le proprie risorse naturali, i propri prodotti alimentari e commerciali, e persino la propria forza lavoro di massa (dipendenti, operai, ricercatori e tecnici, lavoratori in genere) con politiche non solo fiscalmente e tributariamente equilibrate e tollerabili ma anche retributivamente e distributivamente adeguate e al tempo stesso capaci di affrontare la concorrenza internazionale ad alti o più alti livelli di produttività.
Come ha ben rilevato Alberto Bagnai, l’euro si è ormai rivelato per molti paesi, tra cui l’Italia, “insostenibile”. Il problema è dunque quello di uscirne per tempo, cioè prima che sia troppo tardi (vedi Grecia, vedi Cipro). Per il momento, dice Bagnai, «i fondamentali dell’economia italiana sono sostanzialmente buoni, il debito pubblico italiano non è a rischio e il popolo italiano è ancora risparmiatore, quindi ha tutto il vantaggio di tirarsi fuori da questa trappola prima che la propria ricchezza, gli immobili e i risparmi in banca vengano aggrediti dall’Europa per ricapitalizzare quelle banche del nord che hanno sbagliato» [Addio Euro. Come uscirne (senza danni) per non farsi rapinare dall’Europa, in “Economia e Finanza” del 28 marzo 2013]. E’ certamente questo uno dei punti più incontrovertibili dell’analisi di Bagnai. Mai come in questo caso sembra cosí vero il detto secondo cui “il tempo è denaro”, quel denaro di cui l’Italia non può ulteriormente privarsi per non sprofondare nelle acque paludose della miseria e del sottosviluppo. La tempestività dell’azione politica è e sarà una delle condizioni necessarie per un salvataggio non avventuroso ma almeno relativamente tranquillo della vita economica e sociale italiana.
Da questo punto di vista i cattolici, domani impegnati evangelicamente in politica, se ci saranno realmente dovranno essere ambiziosi: non per se stessi ma per la propria gente (e forse per l’intera umanità) e innanzitutto e soprattutto per soddisfare le necessità più impellenti dei ceti e dei soggetti più deboli. Consapevoli, come è ovvio, dell’estrema difficoltà del compito ma anche del fatto che, con Cristo nel cuore e nella mente, nulla è impossibile specialmente se gran parte di un popolo si predisponga di nuovo a credere in Lui e a perseguire il proprio bene in spirito di carità e di giustizia.
L’Italia tra insipienza governativa e incubo europeo
 Il dibattito politico italiano è inconsistente e menzognero. E’ molto probabile che le forze politiche italiane, affette ormai da cronica cecità etica e politica oltre che da una manifesta capacità di elaborare e proporre analisi economiche sufficientemente attendibili, non abbiano dato e non diano alcuna importanza ad articoli-documento come quello molto recente pubblicato da uno studioso italiano della London School of Economics che ha annunciato cosí, con un’analisi assolutamente impeccabile per chiarezza ed obiettività, l’inevitabile declino dell’Italia: “Dell’Italia non rimarrà nulla, in 10 anni si dissolverà” (nel sito “Irib World Service”, giovedì 17 Ottobre 2013).
Il dibattito politico italiano è inconsistente e menzognero. E’ molto probabile che le forze politiche italiane, affette ormai da cronica cecità etica e politica oltre che da una manifesta capacità di elaborare e proporre analisi economiche sufficientemente attendibili, non abbiano dato e non diano alcuna importanza ad articoli-documento come quello molto recente pubblicato da uno studioso italiano della London School of Economics che ha annunciato cosí, con un’analisi assolutamente impeccabile per chiarezza ed obiettività, l’inevitabile declino dell’Italia: “Dell’Italia non rimarrà nulla, in 10 anni si dissolverà” (nel sito “Irib World Service”, giovedì 17 Ottobre 2013).
Ci si riferisce al dottor Roberto Orsi che, descrivendo con precisa cognizione di causa le terrificanti dinamiche in atto nel nostro Paese, prevede, a meno di radicali inversioni di tendenza oggi improbabili, lo sprofondamento dell’Italia in una condizione di decadenza civile e culturale e di estrema povertà economica al massimo entro un decennio: «Gli storici del futuro», egli afferma, «probabilmente guarderanno all’Italia come un caso perfetto di un Paese che è riuscito a passare da una condizione di nazione prospera e leader industriale in soli vent’anni in una condizione di desertificazione economica, di incapacità di gestione demografica, di rampante terzomondializzazione, di caduta verticale della produzione culturale e di un completo caos politico istituzionale». Perché?
Perché anche l’attuale governo Letta, sostanzialmente in linea con i programmi del precedente governo Monti, continua a fare tutto quello che non dovrebbe fare per poter sperare di rimettere realmente in carreggiata il nostro Paese: la supina condiscendenza ad una Unione Europea visibilmente fallimentare, e quindi provvedimenti economici totalmente insufficienti a risollevare il mondo del lavoro e il complessivo mondo produttivo dallo stato di depressione in cui sono precipitati gradualmente e sempre più pesantemente nell’ultimo ventennio. Si pensi all’aumento obiettivamente insensato dell’IVA al 22% che non può che deprimere ulteriormente i consumi, nonostante i «vacui proclami circa la necessità di spostare il carico fiscale dal lavoro e dalle imprese alle rendite finanziarie» e nonostante le ottimistiche ma false e infondate rassicurazioni circa una “imminente ripresa” dell’economia italiana.
In effetti, dopo i numerosi salassi fiscali e tributari imposti senza soluzione di continuità ai cittadini italiani specialmente nell’ultimo decennio, un qualche infinitesimale miglioramento ci sarà anche stato ma esso non può che risultare del tutto insignificante ai fini di una effettiva “ripresa”. Si può dire che, dal governo Monti al governo Letta, si sia verificata «una transizione da una grave recessione a una sorta di stagnazione», cioè qualcosa di irrilevante dal punto di vista economico e sociale. Se si pensa che, prima della crisi, l’Italia era il più grande Stato europeo subito dopo la Germania nel settore manifatturiero e che oggi ne risulta distrutto il 15% con la scomparsa di circa 32.000 aziende, ci si può fare un’idea abbastanza precisa di quali irreparabili danni siano stati arrecati da una politica economica insipiente e irresponsabile e da una politica governativa tout court che negli anni non ha mai voluto capire che «l’apertura indiscriminata ai prodotti industriali a basso costo dell’Asia avrebbe distrutto industrie una volta leader in Italia negli stessi settori».
L’altra faccia della medaglia di questa politica nazionale acriticamente favorevole alla globalizzazione di merci e denaro è consistita nella irresponsabile decisione dell’Italia di firmare i trattati sull’euro con la promessa ai partners europei di impegnarsi a perseguire politiche di austerità e ad attuare riforme che, fortunatamente o sfortunatamente, non sono mai state attuate non già per senso di responsabilità verso il popolo italiano ma solo per il timore che riforme attuate nel segno del liberismo europeista avrebbero potuto determinare sollevamenti popolari incontrollabili.
Ora, viene giustamente rilevato e ribadito senza mezzi termini, «questa situazione ha le sue radici nella cultura politica enormemente degradata dell’élite del Paese, che, negli ultimi decenni, ha negoziato e firmato numerosi accordi e trattati internazionali, senza mai considerare il reale interesse economico del Paese e senza alcuna pianificazione significativa del futuro della nazione. L’Italia non avrebbe potuto affrontare l’ultima ondata di globalizzazione in condizioni peggiori», giacché la globalizzazione, egemonizzata oggi dal grande capitalismo finanziario internazionale, non riguarda solo lo spostamento delle merci da una parte all’altra del mondo ma anche quello sempre più drammatico e frequente di masse di esseri umani (si pensi al fenomeno dell’immigrazione in particolare in Italia ma poi anche in tutte le parti del mondo in cui il capitalismo non ha ancora prodotto condizioni di totale ed irreversibile povertà), che da un lato pongono ulteriori problemi economici (specie ad un Paese di frontiera come l’Italia) e dall’altra non possono che diventare oggetto di uno sfruttamento selvaggio.
Se a queste rovinose dinamiche strutturali che agiscono anarchicamente a livello mondiale senza che siano contrastate da una volontà di restituire, rispetto alle imperanti logiche di progressiva totale espropriazione dei popoli della loro legittima ricchezza, una forte centralità alla politica e a politiche sociali fatte nell’interesse dei popoli e non dei magnati della grande finanza mondiale, si aggiunge che in Italia «un mix fatale di terribile gestione finanziaria, infrastrutture inadeguate, corruzione onnipresente, burocrazia inefficiente, il sistema di giustizia più lento e inaffidabile d’Europa, sta spingendo tutti gli imprenditori fuori dal Paese non solo verso destinazioni che offrono lavoratori a basso costo, come in Oriente o in Asia meridionale ma persino…verso la vicina Svizzera e in Austria dove, nonostante i costi relativamente elevati di lavoro, le aziende troveranno un vero e proprio Stato a collaborare con loro, anziché a sabotarli», il quadro non può non risultare terribilmente fosco per gli stessi sostenitori di un europeismo ad oltranza.
Si dà il caso che nella mente dello stesso Letta qualche dubbio cominci a sorgere se è vero che, come riportato dagli organi di stampa, in un discorso tenuto ieri alla Sorbonne di Parigi egli abbia detto ad un certo punto: «L’Europa non è la causa della “crisi”, ma i problemi attuali come l’elevata disoccupazione vengono dalla “mancanza d’Europa”», dove però il premier italiano evidentemente non si avvede della incongruenza presente nella sua affermazione. Perché se tu ammetti che “i problemi attuali”, come “l’elevata disoccupazione”, «vengono dalla mancanza d’Europa», non dovresti poi concludere che questa Europa reale, che oltre tutto commina irrazionalmente e arbitrariamente pesanti multe o sanzioni pecuniarie anche a causa della cosiddetta eccedenza di beni alimentari preziosi come il latte o gli agrumi o dello stato relativamente fatiscente e inadeguato delle carceri, è solo fonte di guai e di immiserimento materiale e morale? Non dovresti quindi sganciarti da questa Europa per meglio tutelare gli interessi e la dignità del popolo che rappresenti e governi, salvo facendo il principio che, in quanto Paese libero e a pieno titolo sovrano e non suddito o schiavo di autorità sovrastatuali sostanzialmente indifferenti al bene dei popoli, con tutti gli Stati occorra pur sempre collaborare e istituire scambi commerciali e culturali di reciproca utilità?
Peraltro, rileva l’economista italiano della London School of Economics, il declassamento dell’Italia come nazione industriale comporta anche la drammatica conseguenza di una fuga mai cosí massiccia come quella odierna di cervelli ottimamente predisposti ad una ricerca scientifica di alto livello, per cui migliaia di giovani ricercatori, tecnici e scienziati emigrano, oltre che negli USA e in Asia orientale, anche in Paesi europei come la Germania, Francia, Gran Bretagna o Scandinavia, che sulla carta dovrebbero essere tutti concorrenti dell’Italia, dove possono disporre di trattamenti economici di gran lunga più soddisfacenti di quelli che si vedono offerti in Italia.
Tutto questo accade proprio mentre, come forse pochi sanno, l’Italia viene ceduta a pezzi come la Grecia: si pensi, come ha evidenziato il sito “ImolaOggi” il 4 ottobre 2013, alla vendita o piuttosto alla svendita proposta, con tanto di annuncio nel sito “Immobiliare.it”, di isole bellissime come l’isola di Santo Stefano, che è la più piccola isola dell’arcipelago Pontino, vicino alla storica isola di Ventotene, e di altre isole di grande bellezza ambientale-paesaggistica e di notevole richiamo turistico disseminate tra Venezia, la friulana Grado e Messina: veri e propri gioielli nazionali che potrebbero avere ricadute finanziarie notevoli e assolutamente vantaggiose per lo Stato italiano e che invece si ritiene di dover mettere in vendita: incredibile ma vero!
Ora, però, tutto lo sfascio attentamente descritto e spiegato dal nostro esperto economista, si è venuto compiendo anche nel quadro di una progressiva e sia pure tacita violazione della nostra carta costituzionale, in quanto la nostra nazione per molti, troppi anni è stata governata, scrive senza peli sulla lingua il dottor Orsi, «da tecnocrati provenienti dall’ufficio del Presidente Repubblica, i burocrati di diversi ministeri chiave e la Banca d’Italia. Il loro compito è quello di garantire la stabilità in Italia nei confronti dell’UE e dei mercati finanziari a qualsiasi costo. Questo è stato finora raggiunto emarginando sia i partiti politici sia il Parlamento a livelli senza precedenti, e con un interventismo onnipresente e costituzionalmente discutibile del Presidente della Repubblica, che ha esteso i suoi poteri ben oltre i confini dell’ordine repubblicano. L’interventismo del Presidente è particolarmente evidente nella creazione del governo Monti e del governo Letta, che sono entrambi espressione diretta del Quirinale».
Accusa più chiara verso Napolitano e i suoi imbelli complici di sinistra e di destra, incapaci tra l’altro di avere una visione politica a lungo termine, non poteva essere formulata, e non in modo isterico come è solito fare il comico Grillo bensí in termini di pacata e obiettiva razionalità e alla luce di dati empirici francamente inoppugnabili che solo coloro che sono in malafede o completamente soggiogati da categorie economiche ormai obsolete e da un modo totalmente sbagliato di intendere l’attività politica possono ancora ostinarsi a manipolare e a mistificare sul piano della comunicazione sociale. Tutta questa gente, dice Roberto Orsi, sta garantendo semplicemente «la scomparsa dell’Italia», anche se molti cittadini sono stati indotti e continuano ad essere indotti a pensare illusoriamente che Napolitano e compagni stiano invece lavorando al fine di salvare la nostra nazione. In questo modo il declino dell’Italia, in un arco di tempo non superiore a un decennio, è destinato ad essere veramente inarrestabile.
Tanto più inarrestabile se si pensa che, proprio in questi giorni, il Fondo Monetario Internazionale, pur smentendo formalmente talune indiscrezioni di stampa secondo cui esso starebbe già pensando ad applicare un prelievo forzoso del 10% sui redditi e sui conti correnti più consistenti dei cittadini europei e naturalmente anche italiani (ma sino a quando si continuerà a parlare ipocritamente e demagogicamente di redditi più alti dal momento che, di fatto, come dimostra il caso della Grecia, persino ceti agiati ma certamente non ricchi finiscono poi per pagare il prezzo più alto e infame di queste stupefacenti soluzioni praticate cinicamente dall’UE, dalla famigerata Commissione Europea e dal rapacissimo Fondo Monetario Internazionale?) al fine di ridurre i debiti sovrani o l’indebitamento pubblico degli Stati europei finanziariamente più compromessi, ha tuttavia molto sinistramente precisato per bocca del suo portavoce William Murray, che in realtà il Fondo si starebbe dedicando solo ad “un lavoro di analisi” e alla elaborazione di “semplici ipotesi”, al più permettendosi di sottoporre all’attenzione dei governi nazionali europei delle “raccomandazioni”.
Solo gli sprovveduti potrebbero non cogliere qui il modo subdolo e arrogante in cui parlano questi signori della grande finanza internazionale per tentare di mascherare i loro piani criminali. Non è decisamente ora, secondo l’invito più volte espresso in questo sito, che i popoli reagiscano in modo adeguato e che i cattolici intellettualmente e spiritualmente radicati nel vangelo di Cristo entrino presto nell’arena politica?
I ricchi non cantino ancora vittoria!
Uno degli uomini più ricchi della terra come Warren Buffett, noto come re dei mercati finanziari globali ed esponente di punta di un esercito plutocratico chiamato High net worth individuals (individui con un elevato patrimonio finanziario pari almeno a 35 milioni di dollari) e composto da circa 200.000 persone ma suscettibile di continua crescita nonostante la crisi o piuttosto proprio grazie alla crisi, ha dichiarato recentemente con toni trionfalistici che la lotta di classe di cui parlava Marx nell’800 non è affatto finita, come per troppo tempo si è andato dicendo, ma che essa è più che mai viva e vegeta anche se non più guidata egemonicamente come in un passato ormai lontano dalle classi povere bensí dalla classe ricca che starebbe conseguendo vittorie sempre più significative (P. Lambruschi, Marx sconfitto dai super ricchi, in “Avvenire” del 12 settembre 2012).
Buffet si riferisce al fatto che nell’odierno mondo globale i ricchi riescono a rubare ai poveri senza che ciò determini reazioni popolari particolarmente significative in virtù di un supporto intellettuale e culturale, certo élitario ma dotato di articolazioni efficaci in tutte le parti del mondo, che è stato capace di ottenere senza colpo ferire un consenso forse in gran parte passivo ma comunque vastissimo e inimmaginabile anche presso i ceti medi e bassi delle varie popolazioni del mondo. Tale consenso riguarda principalmente un punto: che, per uscire dalla crisi, fossero e sono ancora necessarie misure di austerità perché uno Stato, al pari di una famiglia, può spendere solo in base alle entrate e in esso non c’è sviluppo possibile senza contenimento e riduzione del debito pubblico ovvero senza tagliare la spesa pubblica che comprende anche degli “sprechi” da eliminare ma che non può essere considerata in senso generale come sinonimo di “spreco”.
Questo assunto, che ha fatto incredibilmente breccia nella psicologia delle masse, è manifestamente falso per tutta una serie di ragioni tra cui anche quella per cui non è affatto vero che la crescita economica presupponga necessariamente l’abbassamento o l’azzeramento del debito pubblico e quindi anche il notevole contenimento della spesa sociale, essendo al contrario ben noto come storicamente sia proprio il debito pubblico, che non può essere confuso o identificato con gli sprechi, a finanziare la crescita o la sana economia di uno Stato. Che tuttavia la gente sia stata convinta della ineluttabilità dell’austerità al fine di fronteggiare tanto il debito pubblico quanto la depressione economica è dimostrato dal fatto che, persino in una situazione disperata come quella che si è venuta determinando in Grecia, non è scoppiata alcuna rivoluzione.
Questo dato ovviamente ha finito per incoraggiare l’offensiva capitalistica mondiale volta ad espropriare quanto più possibile tutti i cittadini del mondo delle loro stesse ricchezze o risorse economiche personali e ha fatto quindi sí che tale offensiva portasse ad un graduale smantellamento nei paesi occidentali dello Stato sociale, dei tradizionali diritti dei lavoratori, della sovranità nazionale e della stessa democrazia. E’ sin troppo facile capire che quanto più irreversibile dovesse risultare questo processo di erosione dei tradizionali assetti costituzionali e giuridico-istituzionali degli Stati occidentali, sia pure attraverso abili accorgimenti e manovre di tipo “riformistico” di sicura risonanza mediatica anche se di molto debole impatto sociale ed economico, tanto maggiore sarebbe la possibilità di ricavare profitti ancora e sempre più alti senza grossi traumi.
Purtroppo, questa è la situazione. E’ bene fissare in mente questo concetto: la lotta di classe sarà effettivamente e irreversibilmente vinta dai capitalisti e dunque dai ricchi di tutto il mondo se si consentirà che la crescita, la ripresa economica, la riduzione del debito sovrano e il rifiorire del benessere sociale, passino tranquillamente attraverso la distruzione dello Stato sociale e della democrazia. Questa, in realtà, è solo la più recente e moderna versione di una poliedrica e flessibile ideologia capitalista che, pur sempre identica nei suoi obiettivi classisti di fondo, cerca di adattarsi pragmaticamente ai diversi mutamenti storici. La domanda è: che fare perché tutto questo non accada?
Sarebbe ingenuo pensare, come pare abbiano fatto i trecento economisti firmatari di un documento pubblicato sul Financial Times, La advertencia de los economistas (Il monito degli economisti), 23 settembre 2013, che l’austerità europea sia solo la ricetta sbagliata (perché capace solo di deprimere la domanda di beni e di servizi, di penalizzare il lavoro e l’occupazione, di scoraggiare i consumi e ogni concreta possibilità di ripresa economica sia nel settore produttivo pubblico che in quello privato) di una teoria economica e di previsioni economiche sbagliate, pur ammettendo che in buona fede questo o quell’economista abbia potuto semplicemente sbagliare i suoi calcoli.
Certi cataclismi o disastri economici non si verificano per semplici errori teorici, specialmente quando tendono a perpetuarsi nel tempo. Anche perché se certi errori teorici potessero davvero provocare situazioni cosí devastanti, si avrebbero a quel punto delle ottime ragioni per non tenere più in alcuna considerazione gli economisti medesimi, qualunque cosa dicano o propongano.
Ma cataclismi e disastri sono dovuti invece a qualcosa di decisamente deliberato e di molto più grave: ad una precisa strategia di lotta, elaborata politicamente dalle principali oligarchie finanziarie del mondo e corredata certo di ogni opportuno supporto “teorico-economico-scientifico”, per appropriarsi, sotto l’egida di un certo numero di trattati e di vincoli finanziari resi legittimi solo da una ristrettissima comunità internazionale di politici, banchieri ed esperti di varia estrazione culturale e organici al disegno capitalista, della maggior parte del valore e quindi del denaro prodotto dalla forza-lavoro di massa esercitata in tutti i sistemi produttivi del mondo. Una strategia che comporta, per l’appunto, l’abbattimento del Welfare State e della stessa democrazia nelle stesse nazioni occidentali di più salda e radicata tradizione democratica.
Che fare dunque perché questa ennesima barbarie capitalista non infesti irreversibilmente il mondo sino a farne un pianeta di nuovo segnato dal dominio di pochi padroni su una massa sterminata di schiavi? Si può sempre eccepire che l’analisi qui proposta veicoli in realtà certe visioni “mondialiste” e “complottiste” che al più potrebbero rientrare nella categoria delle semplici supposizioni. Ma, pur ritenendo chi scrive che il mondialismo non sia affatto una semplice supposizione bensí una realtà suffragata da dati ormai inconfutabili (non si capirebbe, per esempio, perché certi esclusivi clubs economico-finanziari di cui fanno parte anche numerosissimi politici ed economisti italiani di alto profilo istituzionale operino periodicamente in totale segretezza e senza far trapelare alcunché delle “decisioni di studio” da essi assunte), in realtà anche economisti che non si professano né mondialisti né complottisti riconoscono chiaramente quale sia il vero problema da risolvere.
Un economista come Emiliano Brancaccio ha di recente rilevato sul suo sito che sino a quando resterà inalterata l’attuale deregolamentazione finanziaria con relativa e completa libertà di movimento internazionale dei capitali, la situazione è destinata a non cambiare o a cambiare verso il peggio: «La verità è che in condizioni di libera circolazione dei capitali – e di relativo smantellamento della produzione pubblica – non è certo la volontà dei singoli ma è il meccanismo di riproduzione capitalistica, con la sua instabilità e le sue crisi, che decide della distribuzione, della composizione e del livello della produzione e dell’occupazione» (“Liberare” i migranti senza “arrestare” i capitali? Un suicidio politico, 10 ottobre 2013), dove peraltro, come si intuisce dal titolo dell’articolo, la scottante e attualissima questione degli “immigrati” che sbarcano ormai ininterrottamente sulle coste italiane viene intelligentemente posta non già solo in rapporto a princípi di ordine giuridico e umanitario ma proprio in rapporto al problema di un necessario ed inedito rilancio di «proposte finalizzate al controllo politico dei movimenti di capitale. Dove per controllo dovrebbe intendersi il ridimensionamento dei mercati finanziari e il riassorbimento, nell’ambito della dialettica politica, della questione cruciale del riequilibrio dei conti esteri. Il ripristino di una rete di controlli sui capitali è una delle condizioni necessarie per impedire che lo scontro distributivo e occupazionale continui ad esprimersi solo tra i lavoratori, in particolare tra nativi e migranti» (ivi).
Ma non è che la messa a punto di questi controlli sui capitali richiedano necessariamente tempi biblici; sarebbe sufficiente che le politiche nazionali degli Stati con maggiori difficoltà di tenuta economica e sociale, a cominciare da quella italiana che potrebbe ben decidersi autonomamente al grande e storico passo, sebbene non privo di insidie, iniziassero a lavorare per spostare il loro baricentro dalla preoccupazione di onorare irrazionali impegni “europei”, che andrebbero assolutamente ridefiniti o rimodulati, alla preoccupazione primaria e inderogabile di tutelare e di come tutelare le proprie comunità nazionali molto meglio di quanto abbiano fatto sinora. Prima che sia troppo tardi: prima che la violenza dei popoli esploda in forme incontrollabili e si contrapponga alla controllata ma criminale violenza di quella classe ricca che sta tanto a cuore al supermagnate americano Warren Buffett.
Noi cattolici non possiamo augurarci che la storia dell’umanità evolva o involva verso forme di aggressività e di lotta primordiali e beluine. Ma, proprio per questo, dovremo impegnarci strenuamente per estirpare il più possibile dal mondo, con le armi pacifiche ma oltremodo efficienti della giustizia e dell’amore evangelici, le radici stesse del male: quel peccato personale e sociale che consiste nel voler negare legittimità alla comune e inviolabile dignità degli esseri umani. Noi cattolici, tra l’altro, dovremo fare di tutto, nel vincolo di amore e di fedeltà a Cristo vivo, per contrastare incisivamente quell’immorale ideologia secondo cui i ricchi sarebbero legittimati non solo ad accumulare smisurate ricchezze ma persino a manipolare direttamente e indirettamente le persone allo scopo di far credere loro che il loro diritto all’arricchimento illimitato sia in fondo giusto e che le uniche ricette valide per combattere la povertà e la regressione economica siano quelle della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e della Banca centrale europea.

