 Non so se avesse completamente ragione Bauman nell’affermare che, nel periodo di transizione dalla modernità alla postmodernità, gli intellettuali, in quanto specifica categoria storico-sociologica nata nel contesto illuministico e meglio caratterizzatasi poi sul finire dell’800 per la sua specifica e duplice funzione di critica sociale e critica del potere, sarebbero venuti gradualmente smarrendo la loro originaria e universalistica funzione di “legislatori”, termine a mio avviso usato impropriamente dal sociologo polacco (meglio sarebbe stato limitarsi ad usare un termine come “giudice culturale”), ovvero la funzione di affrontare e dirimere con indiscussa autorevolezza critica le grandi e generali questioni della verità, dell’eticità e dei costumi sociali della loro epoca, per assumere un più dimesso ruolo di “interprete”, consistente nel ridurre il grado di incomprensione e di incomunicabilità tra tradizioni diverse di pensiero e di cultura e nel descrivere, quanto più analiticamente possibile, la problematicità, la contraddittorietà, la complessità dei processi in atto, anche se la natura per così dire “tecnica”, neutrale, imparziale, di questo approccio programmaticamente non più valutativo, ideologico e politico ma, per l’appunto, basato su giudizi avalutativi, descrittivi, ermeneutico-esplicativi, si sarebbe presto rivelata illusoria1.
Non so se avesse completamente ragione Bauman nell’affermare che, nel periodo di transizione dalla modernità alla postmodernità, gli intellettuali, in quanto specifica categoria storico-sociologica nata nel contesto illuministico e meglio caratterizzatasi poi sul finire dell’800 per la sua specifica e duplice funzione di critica sociale e critica del potere, sarebbero venuti gradualmente smarrendo la loro originaria e universalistica funzione di “legislatori”, termine a mio avviso usato impropriamente dal sociologo polacco (meglio sarebbe stato limitarsi ad usare un termine come “giudice culturale”), ovvero la funzione di affrontare e dirimere con indiscussa autorevolezza critica le grandi e generali questioni della verità, dell’eticità e dei costumi sociali della loro epoca, per assumere un più dimesso ruolo di “interprete”, consistente nel ridurre il grado di incomprensione e di incomunicabilità tra tradizioni diverse di pensiero e di cultura e nel descrivere, quanto più analiticamente possibile, la problematicità, la contraddittorietà, la complessità dei processi in atto, anche se la natura per così dire “tecnica”, neutrale, imparziale, di questo approccio programmaticamente non più valutativo, ideologico e politico ma, per l’appunto, basato su giudizi avalutativi, descrittivi, ermeneutico-esplicativi, si sarebbe presto rivelata illusoria1.
Non so se e in che misura Bauman avesse ragione, ma d’altra parte è naturale che storicamente anche le forme dell’intellettualità, dell’essere intellettuali, siano soggette a mutare, pur senza necessariamente perdere la loro costitutiva vocazione all’universalità. Per esempio, non si può dire che un giornalista postmoderno e postcomunista come Piero Sansonetti sia un intellettuale più descrittivo, più obiettivo e imparziale di quanto non lo fossero certi eminenti intellettuali del primo novecento, magari solo per via di un linguaggio più leggero, agile ed essenziale, anche se meno analitico, meno problematico, meno esauriente ed esaustivo, quale dev’essere quello di chi scrive quotidianamente articoli per i giornali. Ora, proprio un “interprete”, direbbe Bauman, come l’intellettuale democratico-libertario Sansonetti, si chiedeva sarcasticamente, sulle colonne di “Liberazione”, che fine avessero fatto, all’indomani dell’elezione pontificia di Joseph Ratzinger, tutti quei cattolici democratici che per tutta la seconda metà del ’900 avevano contribuito attivamente allo sviluppo della società civile e del sistema democratico, spesso ponendosi come mediazione sensibile e intelligente tra società laica e società religiosa, tra comunità sociale e Chiesa gerarchica, oscurantista e totalitaria, lamentando che quegli stessi intellettuali assistessero ora pavidamente, sotto il pontificato di un papa “reazionario” come Benedetto XVI (questo, in sostanza, era il giudizio che ne dava), allo smantellamento di quella che era stata, negli anni sessanta, la grande costruzione conciliare. E, per contrasto alla pochezza intellettuale che caratterizzava la scena dei cattolici italiani nell’era del papa tedesco, sciorinava tutta una serie di nomi di famosi intellettuali cattolici del bel tempo andato, da Ernesto Balducci a Lorenzo Milani, da Adriani Zarri a padre Turoldo, dai più moderati Pietro Scoppola e Achille Ardigò a sindacalisti combattivi come Livio Labor o Pierre Carniti e, infine, a parlamentari, filosofi ed economisti come Franco Ròdano, Giuseppe Gozzini, Claudio Napoleoni. Tutti nomi noti, se si vuole anche celebri e popolari, più che altro per le frequenti celebrazioni giornalistiche loro dedicate per via del particolare piglio caratteriale e di una certa carica critico-contestativa non identica per tutti indistintamente, che ne caratterizzavano gli studi e le prese di posizione spesso polemiche su questioni culturali o di quotidiana attualità, e che soprattutto riempivano i giornali a causa di quel loro cattolicesimo talvolta controcorrente o antistituzionale. Continua a leggere→
Post Views:
870
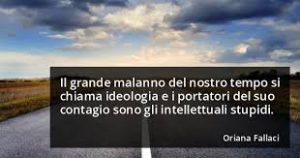 trattandolo come una sorta di spazio europeo riservato all’accoglienza e magari all’integrazione di tutti i migranti che tocchino, legalmente o illegalmente, le coste italiane, nel nome di un diritto internazionale e di trattati europei che, di fatto, sembrano condannare al momento l’Italia a farsi carico di tutti i disperati del mondo. Ma i nemici interni sono molto più temibili e ben più corrosivi, per il semplice fatto che un organismo ancora integro riesce ancora a difendersi adeguatamente da pericoli o attacchi esterni, mentre un organismo già minato all’interno e sottoposto quindi ad uno stress elevato specie se prolungato, ha maggiori difficoltà a resistere efficacemente a minacce di origine esterna su esso incombenti. Continua a leggere
trattandolo come una sorta di spazio europeo riservato all’accoglienza e magari all’integrazione di tutti i migranti che tocchino, legalmente o illegalmente, le coste italiane, nel nome di un diritto internazionale e di trattati europei che, di fatto, sembrano condannare al momento l’Italia a farsi carico di tutti i disperati del mondo. Ma i nemici interni sono molto più temibili e ben più corrosivi, per il semplice fatto che un organismo ancora integro riesce ancora a difendersi adeguatamente da pericoli o attacchi esterni, mentre un organismo già minato all’interno e sottoposto quindi ad uno stress elevato specie se prolungato, ha maggiori difficoltà a resistere efficacemente a minacce di origine esterna su esso incombenti. Continua a leggere
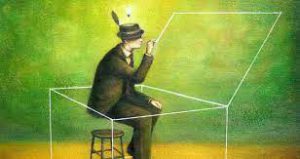 La società globale è una società in cui le ideologie, ufficialmente dissoltesi e inesistenti, sopravvivono tuttavia nell’inconscio di politici e intellettuali relativamente giovani che si guardano bene tuttavia dal manifestare in forma pubblica antichi rimpianti, nostalgie di idee e modelli sociali ormai anacronistici, tradizionali esigenze teorico-pratiche di natura organicistica e totalizzante. Ormai, è sempre più difficile trovare partiti che siano organici alla base sociale di riferimento se non per ragioni prevalentemente strumentali ed elettorali, e politici e intellettuali disposti a rendersi gramscianamente funzionali ad un’opera di educazione o rieducazione intellettuale e morale delle masse.
La società globale è una società in cui le ideologie, ufficialmente dissoltesi e inesistenti, sopravvivono tuttavia nell’inconscio di politici e intellettuali relativamente giovani che si guardano bene tuttavia dal manifestare in forma pubblica antichi rimpianti, nostalgie di idee e modelli sociali ormai anacronistici, tradizionali esigenze teorico-pratiche di natura organicistica e totalizzante. Ormai, è sempre più difficile trovare partiti che siano organici alla base sociale di riferimento se non per ragioni prevalentemente strumentali ed elettorali, e politici e intellettuali disposti a rendersi gramscianamente funzionali ad un’opera di educazione o rieducazione intellettuale e morale delle masse.
 Io sono, come i lettori sanno, un cattolico democratico di ispirazione personalistica e comunitaria. In passato, ma circa 30-35 anni or sono, mi presentai alle elezioni regionali della Calabria, nelle file di Democrazia Proletaria, come indipendente di sinistra. Fu un insuccesso, ma non è questo il punto. Oggi penso di conoscere bene l’anima della sinistra e di molti democratici, ed è per questo che non temo di considerare il recente successo politico-elettorale di Giorgia Meloni come un segno di speranza, come motivo di fiducia in un futuro politico nazionale migliore.
Io sono, come i lettori sanno, un cattolico democratico di ispirazione personalistica e comunitaria. In passato, ma circa 30-35 anni or sono, mi presentai alle elezioni regionali della Calabria, nelle file di Democrazia Proletaria, come indipendente di sinistra. Fu un insuccesso, ma non è questo il punto. Oggi penso di conoscere bene l’anima della sinistra e di molti democratici, ed è per questo che non temo di considerare il recente successo politico-elettorale di Giorgia Meloni come un segno di speranza, come motivo di fiducia in un futuro politico nazionale migliore.  Non so se e fino a che punto sia vero che, morti tanti grandi maestri del passato, la società italiana di questo inizio di terzo millennio sia ormai rimasta orfana di luminosi fari culturali, di importanti guide spirituali, di significativi punti morali e civili di riferimento, anche se, appartenendo ad una fase avanzata della vita in cui generalmente si diventa più saggi ed equilibrati, confesso di non ricordare specifici periodi storici del secolo scorso e del primo ventennio di questo secolo, in cui, pure nel quadro di impegnativi e talvolta infuocati dibattiti culturali ed etico-politici, qualcuno di quei rimpianti maestri riuscisse in qualche modo ad egemonizzarli o, più semplicemente, ad esercitare una speciale influenza sulla pubblica opinione. Credo che, morto Benedetto Croce, e per motivi beninteso del tutto contingenti, papi della cultura nazionale, non ve ne siano più stati. E forse è stato un bene perché la cultura, a differenza della vita religiosa, non può svolgersi, non può svilupparsi e progredire se vi siano papi a dirigerla ma anche a regolamentarla, disciplinarla, limitarla.
Non so se e fino a che punto sia vero che, morti tanti grandi maestri del passato, la società italiana di questo inizio di terzo millennio sia ormai rimasta orfana di luminosi fari culturali, di importanti guide spirituali, di significativi punti morali e civili di riferimento, anche se, appartenendo ad una fase avanzata della vita in cui generalmente si diventa più saggi ed equilibrati, confesso di non ricordare specifici periodi storici del secolo scorso e del primo ventennio di questo secolo, in cui, pure nel quadro di impegnativi e talvolta infuocati dibattiti culturali ed etico-politici, qualcuno di quei rimpianti maestri riuscisse in qualche modo ad egemonizzarli o, più semplicemente, ad esercitare una speciale influenza sulla pubblica opinione. Credo che, morto Benedetto Croce, e per motivi beninteso del tutto contingenti, papi della cultura nazionale, non ve ne siano più stati. E forse è stato un bene perché la cultura, a differenza della vita religiosa, non può svolgersi, non può svilupparsi e progredire se vi siano papi a dirigerla ma anche a regolamentarla, disciplinarla, limitarla. Non so se avesse completamente ragione Bauman nell’affermare che, nel periodo di transizione dalla modernità alla postmodernità, gli intellettuali, in quanto specifica categoria storico-sociologica nata nel contesto illuministico e meglio caratterizzatasi poi sul finire dell’800 per la sua specifica e duplice funzione di critica sociale e critica del potere, sarebbero venuti gradualmente smarrendo la loro originaria e universalistica funzione di “legislatori”, termine a mio avviso usato impropriamente dal sociologo polacco (meglio sarebbe stato limitarsi ad usare un termine come “giudice culturale”), ovvero la funzione di affrontare e dirimere con indiscussa autorevolezza critica le grandi e generali questioni della verità, dell’eticità e dei costumi sociali della loro epoca, per assumere un più dimesso ruolo di “interprete”, consistente nel ridurre il grado di incomprensione e di incomunicabilità tra tradizioni diverse di pensiero e di cultura e nel descrivere, quanto più analiticamente possibile, la problematicità, la contraddittorietà, la complessità dei processi in atto, anche se la natura per così dire “tecnica”, neutrale, imparziale, di questo approccio programmaticamente non più valutativo, ideologico e politico ma, per l’appunto, basato su giudizi avalutativi, descrittivi, ermeneutico-esplicativi, si sarebbe presto rivelata illusoria1.
Non so se avesse completamente ragione Bauman nell’affermare che, nel periodo di transizione dalla modernità alla postmodernità, gli intellettuali, in quanto specifica categoria storico-sociologica nata nel contesto illuministico e meglio caratterizzatasi poi sul finire dell’800 per la sua specifica e duplice funzione di critica sociale e critica del potere, sarebbero venuti gradualmente smarrendo la loro originaria e universalistica funzione di “legislatori”, termine a mio avviso usato impropriamente dal sociologo polacco (meglio sarebbe stato limitarsi ad usare un termine come “giudice culturale”), ovvero la funzione di affrontare e dirimere con indiscussa autorevolezza critica le grandi e generali questioni della verità, dell’eticità e dei costumi sociali della loro epoca, per assumere un più dimesso ruolo di “interprete”, consistente nel ridurre il grado di incomprensione e di incomunicabilità tra tradizioni diverse di pensiero e di cultura e nel descrivere, quanto più analiticamente possibile, la problematicità, la contraddittorietà, la complessità dei processi in atto, anche se la natura per così dire “tecnica”, neutrale, imparziale, di questo approccio programmaticamente non più valutativo, ideologico e politico ma, per l’appunto, basato su giudizi avalutativi, descrittivi, ermeneutico-esplicativi, si sarebbe presto rivelata illusoria1.  Accademico solo per collocazione professionale, non certo per mentalità e metodologia di lavoro, intellettuale atipico e anticonformista ancora oggi abbastanza misconosciuto e sottovalutato. Di scrittura non sempre chiara, lineare e ordinata, benché significativa ed originale su temi essenziali, ma teoricamente e concettualmente lucido; militante cattolico alieno da ogni forma di bigottismo e di ideologia religiosa, ma dedito a servire la causa evangelica con uno spirito missionario talvolta sin troppo zelante e inquieto. Intellettuale imparziale ma non neutrale, realista ma controcorrente e inattuale. Un uomo di fede con la passione del finito e del sociale ma con l’ansia esistenziale dell’infinito e dell’eterno, un apostolo laico e un pensatore cattolico con la vocazione a indagare le corde più sensibili e vitali dell’esistenza personale e a produrre conoscenza in funzione di una piena ma realistica emancipazione dell’uomo-operaio nel quadro di comunità piccole ma solidali di lavoro.
Accademico solo per collocazione professionale, non certo per mentalità e metodologia di lavoro, intellettuale atipico e anticonformista ancora oggi abbastanza misconosciuto e sottovalutato. Di scrittura non sempre chiara, lineare e ordinata, benché significativa ed originale su temi essenziali, ma teoricamente e concettualmente lucido; militante cattolico alieno da ogni forma di bigottismo e di ideologia religiosa, ma dedito a servire la causa evangelica con uno spirito missionario talvolta sin troppo zelante e inquieto. Intellettuale imparziale ma non neutrale, realista ma controcorrente e inattuale. Un uomo di fede con la passione del finito e del sociale ma con l’ansia esistenziale dell’infinito e dell’eterno, un apostolo laico e un pensatore cattolico con la vocazione a indagare le corde più sensibili e vitali dell’esistenza personale e a produrre conoscenza in funzione di una piena ma realistica emancipazione dell’uomo-operaio nel quadro di comunità piccole ma solidali di lavoro.