 1. L’apologia idealistica del pensiero operata da Giovanni Gentile non appare destinata ad avere un destino storico-filosofico di gloria per la semplice ragione che ciò che il teorico dell’attualismo è venuto esaltando non è il pensiero inteso nella vasta gamma delle sue potenzialità critiche ma una semplice, univoca e dogmatica forma di pensiero, verosimilmente incapace di rendere conto della proteiforme complessità della realtà e del sapere1. Ed è molto difficile che il pensiero gentiliano, non necessariamente a causa dell’ostinata adesione di Gentile al «partito dei vinti della storia», possa ancora influire sulla cultura italiana del XXI secolo e dei secoli a venire nella stessa misura in cui, godendo di una posizione politica di assoluto e preconcetto privilegio, potette influire sulla cultura nazionale dei primi decenni del secolo scorso2.Tuttavia, esso merita di essere ripensato criticamente perché se, sotto l’aspetto logico-linguistico-metodologico, appare irrimediabilmente anacronistico e inutilizzabile, e sul piano politico e ideologico il suo orientamento non può più essere equivocato3 dal punto di vista pedagogico, etico-civile e filosofico-religioso, appare ancora ricco di suggerimenti, spunti, provocazioni utili a rideterminare il grado di validità o di insufficienza teorico-pratica e spirituali di alcuni fondamentali paradigmi della vita civile e culturale di questo tempo. Continua a leggere
1. L’apologia idealistica del pensiero operata da Giovanni Gentile non appare destinata ad avere un destino storico-filosofico di gloria per la semplice ragione che ciò che il teorico dell’attualismo è venuto esaltando non è il pensiero inteso nella vasta gamma delle sue potenzialità critiche ma una semplice, univoca e dogmatica forma di pensiero, verosimilmente incapace di rendere conto della proteiforme complessità della realtà e del sapere1. Ed è molto difficile che il pensiero gentiliano, non necessariamente a causa dell’ostinata adesione di Gentile al «partito dei vinti della storia», possa ancora influire sulla cultura italiana del XXI secolo e dei secoli a venire nella stessa misura in cui, godendo di una posizione politica di assoluto e preconcetto privilegio, potette influire sulla cultura nazionale dei primi decenni del secolo scorso2.Tuttavia, esso merita di essere ripensato criticamente perché se, sotto l’aspetto logico-linguistico-metodologico, appare irrimediabilmente anacronistico e inutilizzabile, e sul piano politico e ideologico il suo orientamento non può più essere equivocato3 dal punto di vista pedagogico, etico-civile e filosofico-religioso, appare ancora ricco di suggerimenti, spunti, provocazioni utili a rideterminare il grado di validità o di insufficienza teorico-pratica e spirituali di alcuni fondamentali paradigmi della vita civile e culturale di questo tempo. Continua a leggere

 Sin dal 1928, quando viene condannato dal tribunale fascista a circa vent’anni di carcere, Gramsci è un comunista antidogmatico e democratico, convinto che il verbo comunista dovesse respirare con le anime di tutte le sue componenti storiche, di tutte le forze teorico-pratiche che vi si riconoscessero. Il comunismo, per lui, aveva nel liberalismo un presupposto imprescindibile, nel senso che il suo potenziale rivoluzionario, sul piano sociale ed economico, si sarebbe potuto pienamente esplicare solo ove gli ordinamenti giuridico-politici ed istituzionali liberali avessero già costituito un dato di fatto. Era tuttavia intransigente sulla fedeltà da prestare ai princìpi e ai fini programmatici del partito, ai valori etico-politici che ne erano a fondamento, e sulla integrità e coerenza morale con cui occorreva interpretare il proprio ruolo di militante rivoluzionario. La grande intelligenza teorico-politica, l’ingegnosa duttilità tattico-strategica, si coniugavano in lui perfettamente con l’appassionata e coraggiosa vocazione missionaria ad onorare e a dare compimento, a qualunque costo, alla propria fede politica e alla propria causa di liberazione umana.
Sin dal 1928, quando viene condannato dal tribunale fascista a circa vent’anni di carcere, Gramsci è un comunista antidogmatico e democratico, convinto che il verbo comunista dovesse respirare con le anime di tutte le sue componenti storiche, di tutte le forze teorico-pratiche che vi si riconoscessero. Il comunismo, per lui, aveva nel liberalismo un presupposto imprescindibile, nel senso che il suo potenziale rivoluzionario, sul piano sociale ed economico, si sarebbe potuto pienamente esplicare solo ove gli ordinamenti giuridico-politici ed istituzionali liberali avessero già costituito un dato di fatto. Era tuttavia intransigente sulla fedeltà da prestare ai princìpi e ai fini programmatici del partito, ai valori etico-politici che ne erano a fondamento, e sulla integrità e coerenza morale con cui occorreva interpretare il proprio ruolo di militante rivoluzionario. La grande intelligenza teorico-politica, l’ingegnosa duttilità tattico-strategica, si coniugavano in lui perfettamente con l’appassionata e coraggiosa vocazione missionaria ad onorare e a dare compimento, a qualunque costo, alla propria fede politica e alla propria causa di liberazione umana. Il male assoluto, secondo Hannah Arendt, consiste nell’uccisione, nella deliberata o pianificata eliminazione fisica non solo di politici, criminali o soggetti comunque colpevoli di aver violato gravemente qualche fondamentale legge dello Stato o qualche importante principio morale, di aver commesso gravi reati contro le persone o una determinata collettività, ma anche di gruppi di «innocenti in ogni senso», di tutti coloro che, in Germania, dopo il 1938, «per una ragione qualsiasi estranea alle loro azioni, erano caduti in disgrazia»: gli ebrei in primis, gli zingari, gli omosessuali, ogni genere di minoranza atipica. Il male assoluto è un male non riconducibile ad alcun principio di razionalità morale e giuridica, di razionalità tout court, perché è semplicemente irrazionale, mostruosamente irrazionale, non tanto condannare a morte qualcuno ma soprattutto condannare qualcuno a morire tra indicibili e orribili torture e strazi volti a privarlo della sua dignità, della sua stessa natura umana.
Il male assoluto, secondo Hannah Arendt, consiste nell’uccisione, nella deliberata o pianificata eliminazione fisica non solo di politici, criminali o soggetti comunque colpevoli di aver violato gravemente qualche fondamentale legge dello Stato o qualche importante principio morale, di aver commesso gravi reati contro le persone o una determinata collettività, ma anche di gruppi di «innocenti in ogni senso», di tutti coloro che, in Germania, dopo il 1938, «per una ragione qualsiasi estranea alle loro azioni, erano caduti in disgrazia»: gli ebrei in primis, gli zingari, gli omosessuali, ogni genere di minoranza atipica. Il male assoluto è un male non riconducibile ad alcun principio di razionalità morale e giuridica, di razionalità tout court, perché è semplicemente irrazionale, mostruosamente irrazionale, non tanto condannare a morte qualcuno ma soprattutto condannare qualcuno a morire tra indicibili e orribili torture e strazi volti a privarlo della sua dignità, della sua stessa natura umana. 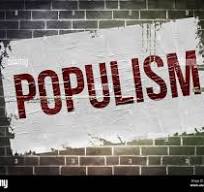 Liberissimi di pensare che una democrazia governativa di tipo tecnico e apolitico, governi populisti promossi da spinte popolari di natura tendenzialmente plebiscitaria, costituiscano deformazioni della democrazia che la spingerebbero a travalicare i limiti della carta costituzionale e ad imboccare la strada di regimi dittatoriali. Ma non altrettanto liberi di pretendere che, qualunque forma politico-governativa venga assumendo la democrazia, sulla base di libere e pacifiche determinazioni delle masse popolari e dei loro rappresentanti e nei limiti del rispetto formale delle leggi e delle regole costitutive dell’ordinamento democratico, possa non essere compatibile con il metodo e il sistema democratici di vita politica. Ancora più arbitrario e contraddittorio con lo stesso assunto di una originaria purezza democratica è l’idea che una vera democrazia, oltre che su libere elezioni, dovrebbe poter contare anche sulla facoltà istituzionale degli elettori di esercitare un controllo continuo, ossessivo, asfissiante sull’attività del governo in carica e, nel caso, di esigere un ritorno alle urne, perché ad un governo, tranne che non venga operando scelte politiche e amministrative inequivocabilmente e reiteratamente dannose e antitetiche ai legittimi interessi del popolo, occorre dare il tempo di porre in essere, in misura sufficientemente ampia, il proprio programma, prima che i cittadini abbiano la possibilità di valutarne, non per capriccio ma con precisa cognizione di causa, pregi e limiti, e di ritenerne eventualmente necessaria la sostituzione con una diversa compagine politico-governativa.
Liberissimi di pensare che una democrazia governativa di tipo tecnico e apolitico, governi populisti promossi da spinte popolari di natura tendenzialmente plebiscitaria, costituiscano deformazioni della democrazia che la spingerebbero a travalicare i limiti della carta costituzionale e ad imboccare la strada di regimi dittatoriali. Ma non altrettanto liberi di pretendere che, qualunque forma politico-governativa venga assumendo la democrazia, sulla base di libere e pacifiche determinazioni delle masse popolari e dei loro rappresentanti e nei limiti del rispetto formale delle leggi e delle regole costitutive dell’ordinamento democratico, possa non essere compatibile con il metodo e il sistema democratici di vita politica. Ancora più arbitrario e contraddittorio con lo stesso assunto di una originaria purezza democratica è l’idea che una vera democrazia, oltre che su libere elezioni, dovrebbe poter contare anche sulla facoltà istituzionale degli elettori di esercitare un controllo continuo, ossessivo, asfissiante sull’attività del governo in carica e, nel caso, di esigere un ritorno alle urne, perché ad un governo, tranne che non venga operando scelte politiche e amministrative inequivocabilmente e reiteratamente dannose e antitetiche ai legittimi interessi del popolo, occorre dare il tempo di porre in essere, in misura sufficientemente ampia, il proprio programma, prima che i cittadini abbiano la possibilità di valutarne, non per capriccio ma con precisa cognizione di causa, pregi e limiti, e di ritenerne eventualmente necessaria la sostituzione con una diversa compagine politico-governativa.
