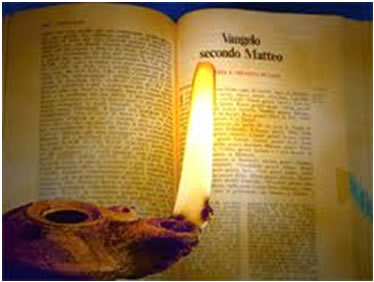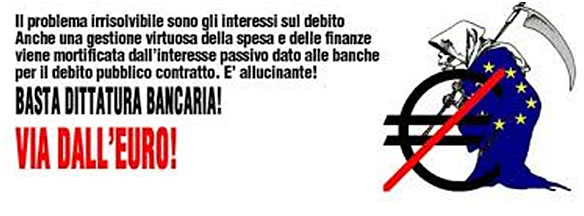L’economia mondiale, cosí com’è, cosí come funziona adesso, non va bene per niente. Non è possibile continuare a pensare che essa possa sussistere e produrre ricchezza in conformità al principio del profitto illimitato e comunque del massimo guadagno possibile e in costante violazione di elementari princípi di umanità e di giustizia sociale, che è spesso ciò che passa completamente sotto silenzio nelle ricorrenti analisi di tanti dotti ma ciechi economisti. Se l’attività economica viene fondata essenzialmente sull’avidità, essa non può che dar luogo a comportamenti «in cui il conflitto di interessi è prassi quotidiana». Per troppo tempo è accaduto che «la cultura del conflitto di interessi» fosse tollerata quasi si trattasse di un dato ineluttabile e che essa tentasse di nascondersi o camuffarsi attraverso un uso strumentale dell’etica, della filosofia, dell’antropologia, «mediante discorsi pomposi e retorici, codici etici e di responsabilità sociale quasi sempre teorici, forti solo della gran cassa mediatica. Ma un tale sistema che mortificava e strumentalizzava l’etica della virtù, la filosofia del bene comune, l’antropologia umanizzante non poteva reggere a lungo» (C. Tabarro, Crisi finanziaria e conflitto di interessi – prima parte –, La proposta della Dottrina sociale della Chiesa, in “Zenit” del 23 agosto 2012).
Questo veniva evidenziando nella sua enciclica “Caritas in Veritate” Benedetto XVI, che criticava anche l’abuso dell’aggettivo “etico”, adoperato troppo spesso in modo generico e quindi in modo tale da prestarsi «a designare contenuti anche molto diversi, al punto da far passare sotto la sua copertura decisioni e scelte contrarie alla giustizia e al vero bene dell’uomo», in evidente contrasto con ciò che insegna la dottrina sociale della Chiesa che ha i suoi due punti fermi «nell’inviolabile dignità della persona umana» e «nel valore trascendente delle norme morali naturali». Per cui, «un’etica economica che prescindesse da questi due pilastri rischierebbe inevitabilmente di perdere la propria connotazione e di prestarsi a strumentalizzazioni; più precisamente essa rischierebbe di diventare funzionale ai sistemi economico-finanziari esistenti, anziché correttiva delle loro disfunzioni. Tra l’altro, finirebbe anche per giustificare il finanziamento di progetti che etici non sono», come recita testualmente l’enciclica “Caritas in Veritate” , n. 45.
Sta di fatto che, ad un certo punto, la cultura del conflitto di interessi con tutte le conseguenze che ne sono derivate, ha prodotto la situazione disastrosa che tutti, e in particolare i ceti e gli individui più poveri o meno abbienti, stiamo vivendo. Il neoliberismo utilitarista che, specialmente nell’ultimo decennio, è diventato il credo indiscusso di una cospicua pluralità di responsabili della politica, dell’economia e della finanza, della stessa cultura, non solo si è dimostrato totalmente fallimentare ma, per mezzo di un sistematico e assordante bombardamento mediatico, ha indotto anche la gran parte delle masse lavoratrici ad un atteggiamento tendenzialmente passivo e rinunciatario nonché troppo condizionato dal timore di poter solo danneggiare il proprio stato di vita con una diversa condotta politica. Le diseguaglianze sono cosí aumentate sia in quantità che in qualità e, in luogo di un’era di maggior sviluppo e di maggior benessere per tutti come falsamente avevano profetizzato i moltissimi corifei del liberismo economico, è venuta ultimamente affermandosi una politica dell’austerità «verso le classi più deboli dalle quali si vorrebbe far dipendere la crescita, mentre ha l’unico effetto di aumentare la depressione e di rendere impossibile la crescita e quindi le future possibilità di pagamento del debito» (C. Tabarro, Crisi finanziaria e conflitto di interessi – prima parte –, La proposta della Dottrina sociale della Chiesa, in “Zenit” del 23 agosto 2012).
Tutto questo è venuto pensando ed elaborando intelligentemente e responsabilmente la Chiesa istituzionale e almeno una parte della Chiesa tout court intorno all’angosciosa crisi finanziaria ed economica in atto. Il papa ha sottolineato l’urgenza di una riforma radicale tanto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite quanto della stessa “architettura economica e finanziaria internazionale”. Ove non si proceda in tale direzione, non si capisce come «sia possibile combattere il conflitto di interessi che “regola” i rapporti tra grande finanza e politica», essendo ben noto che quest’ultima è abbondantemente finanziata e dunque negativamente condizionata dalla prima. Non è forse vero, per esempio, che persino la Corte Suprema americana, con la decisione Citizen United, ha legalizzato nel 2010 la possibilità dei candidati politici di ricevere “donazioni” illimitate? Dov’è la morale, dov’è l’etica pubblica, se persino coloro che dovrebbero custodire gelosamente il diritto in assoluto spirito di indipendenza si prestano a favorire istanze particolaristiche di individui e gruppi?
L’8 maggio 2012, il presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, mons. Mario Toso, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica a competenza universale”, affermando chiaramente che la causa primaria della crisi finanziaria dovesse essere individuata in «un liberismo economico senza regole e senza controlli». E l’analisi, sempre centrata su quest’ultimo, cosí proseguiva e veniva significativamente articolandosi: «Si tratta di una ideologia, di una forma di “apriorismo economico”, che pretende di prendere dalla teoria le leggi di funzionamento del mercato e le cosiddette leggi dello sviluppo capitalistico esasperandone alcuni aspetti. Un’ideologia economica che stabilisca a priori le leggi del funzionamento del mercato e dello sviluppo economico, senza confrontarsi con la realtà, rischia di diventare uno strumento subordinato agli interessi dei Paesi che godono di fatto di una posizione di vantaggio economico e finanziario».
La Nota del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace del 24 ottobre 2011 affermava «l’esistenza di istituzioni ed imprese che, grazie al loro potere e alle informazioni asimmetriche di cui “godono” (o che “costruiscono”), assumono di fatto una posizione di vantaggio economico e finanziario, alias conflitto di interessi. È il conflitto di interessi che ha permesso alla più grande banca d’affari, la Goldman Sachs, di passare indenne dai processi per i drammi sociali, economici e finanziari provocati con i mutui subprime, per le manipolazioni del mercato mondiale, per le responsabilità nell’aver provocato la nazionalizzazione dell’Aig (con i soldi dei contribuenti), per aver stipulato polizze assicurative speculative a copertura di titoli finanziari falliti.
È il conflitto di interessi che ha dato vita al recente scandalo del LIBOR (London inter bank offered rate), il più importante tasso d’interesse interbancario che ogni mattina diciannove banche globali concordano stabilendo i tassi sui prestiti alle imprese e famiglie.
Nonostante tutti questi scandali e tutte queste rovine materiali e morali, per i responsabili non ci sarà nessuna conseguenza giuridica (al massimo una “piccola” sanzione economica), perché le grandi banche sono too big to fail (troppo grandi per fallire) e a loro non si applica il diritto vigente, quindi sarà sempre loro permesso un salvacondotto a causa del conflitto di interessi in gioco.
Abbiamo visto il declino morale delle elargizioni di cospicui bonus a manager anche quando questi hanno distrutto il tessuto economico delle società da loro guidate. Il conflitto di interesse, con l’ausilio dei grandi media (anche loro controllati nella proprietà dalla grande finanza), provoca il sonno della ragione e della morale, e spinge gli animal spirit (nel senso keynesiano) ad emergere contro il bene comune.
Quel che più impressiona è come non ci si accorga che insieme all’elementare ed errata ideologia che vede nel ‘mercatismo’ la risoluzione di tutti i problemi, non si comprenda come l’utilitarismo filosofico di Jeremy Bentham non sia la risposta al problema della crisi ma è piuttosto la causa della crisi.
Si è affermata la convinzione che la massimizzazione dell’utilità non valga soltanto per chi detiene poteri piccoli e grandi, ma addirittura che la logica del conflitto di interessi sia “normale” anche per i legislatori, i quali dovrebbero non pensare al proprio tornaconto ma al bene comune, sulla scia di quanto affermava De Gasperi: “il politico è quello che guarda alle prossime elezioni, lo statista è quello che guarda alle prossime generazioni”» (Crisi finanziaria e conflitto di interessi – seconda parte –, pubblicata sempre in “Zenit”, il 30 agosto 2012).
Che è un’analisi impeccabile anche se ancora caratterizzata dalla tacita convinzione che il capitalismo sia riformabile e non debba essere necessariamente “superato”, e un’analisi implicitamente e fortemente critica, specialmente nella sua parte conclusiva, nei confronti del governo italiano in carica e del suo presidente, prof. Mario Monti, che però ha fatto finta di non sentire e ha pertanto rinunciato a replicare in modo diretto a mons. Toso. Ma resta comunque significativa ed altamente apprezzabile questa presa di posizione della Chiesa cattolica, nella quale tuttavia soprattutto in materia economica e sociale non sussiste una unanimità di punti di vista (e questo spiega la discontinuità dei suoi stessi vertici nello stigmatizzare le severe ma spesso dissennate politiche di revisione della spesa e dei conti pubblici dello Stato italiano che dovrebbero aiutare a superare la crisi ma che in realtà l’aggravano ulteriormente), contro l’ideologia mercatistica, che, muovendo da Jeremy Bentham, è venuta sempre più radicalizzandosi nel secolo scorso in alcuni teorici conservatori, e per aspetti non inessenziali decisamente reazionari, quali Hayek e Friedman (esponenti della cosiddetta “scuola austriaca”), e infine in Robert Nozick, che ne ha ripreso e sviluppato le tesi fondamentali giungendo ad elaborare una critica micidiale del concetto di giustizia distributiva. Sono proprio le politiche ispirate alle teorie di costoro che «giustificano la centralità del conflitto di interessi, oltre a distruggere i diritti e i valori fondamentali della civiltà occidentale fondata sui valori ebraico-cristiani» (ivi).
Tuttavia, questa combattività critico-evangelica sembra appannarsi ed arenarsi leggermente là dove si passa dalla pars destruens alla pars construens, perché è senz’altro opportuno il richiamarsi della Chiesa all’etica del bene comune e il proporre nuove istituzioni politiche, finanziarie e monetarie fondate su tale etica, ed è altrettanto comprensibile che essa, nell’intervenire su questioni economiche e sociali, debba muoversi solo sul piano della sua competenza etica e religiosa, per cui non le è consentito di «entrare nell’agone “politico-partitico” o dare risposte specificatamente tecniche, pur non ignorandole» (Crisi finanziaria e conflitto di interessi – parte terza – in “Zenit” del 6 settembre 2012), ma quel che appare obiettivamente mancante o almeno insufficiente, non già su un piano politico, bensí proprio sul terreno della testimonianza apostolica e del magistero ecclesiale contemporaneo è una chiara e perentoria traduzione e comunicazione dei valori evangelici di condivisione, di comunione, di giustizia sociale oltre che di giustizia tout court in un linguaggio e in un discorso non ovattato o addolcito ma fermo e imperioso come quello con cui Gesù disse: “Beati i poveri, gli umili, gli affamati, gli onesti, i perseguitati…perché essi andranno in cielo e vivranno gioiosamente per l’eternità” e “Guai a voi ricchi, a voi potenti, a voi avidi e incapaci di vera carità, a voi superbi che vorreste caricare gli altri di pesi insopportabili che non toccate neppure con un dito (Lc 11, 46) perché, persistendo il vostro stato di peccato, andrete dritti all’inferno dove sperimenterete per sempre la lontananza da Dio”.
Qui, insomma, la Chiesa è chiamata “a portare la spada”, la stessa spada portata da Cristo, e quindi a portare la divisione, il conflitto, la lotta nelle coscienze di tutti e di ciascuno, prima di portare pace e riconciliazione non già in senso generico e aprioristico ma solo in quanto ci si voglia pacificare e riconciliare con Dio e con gli uomini sul terreno appunto della condivisione, di un’equa distribuzione di beni materiali e spirituali, di una volontà di servire prima gli ultimi e i più bisognosi e poi via via tutti gli altri. Non sta forse scritto che misericordia e verità devono incontrarsi e che giustizia e pace devono baciarsi (Salmo 85, 11)?
E’ senz’altro utile porre in evidenza che a determinare la crisi economica e finanziaria internazionale di questo tempo sono state «le ideologie neoliberiste, neo-utilitariste e tecnocratiche che strumentalizzano il bene comune, affermando che quest’ultimo coincide con la massimizzazione delle utilità economiche, finanziarie e tecniche, non accorgendosi o sottostimando il rischio presente e futuro delle stesse istituzioni democratiche» (ivi), ma non è sufficiente affermare che la Dottrina sociale della Chiesa, «per superare questo impianto ideologico e le sue prassi distorte, propone di partire da un nuovo umanesimo globale, aperto alla trascendenza, fondato sull’etica della fraternità e della solidarietà, nonché subordinando l’economia e la finanza alla politica, responsabile del bene comune», e che solo in questo modo «si possono vincere le idolatrie del ‘mercatismo’ e del conflitto di interessi, aventi come unico fine l’utilitarismo spacciato per felicità, ignorando quell’etica della virtù che li dovrebbe permeare intimamente» (ivi).
Non è sufficiente perché il problema della testimonianza evangelica non è quello di una semplice e distaccata critica dell’esistente ma quello di turbare le menti e scuotere le coscienze di credenti e non credenti per mezzo di forme e di tonalità espressive e concettuali, per l’appunto evangeliche, che, senza altre preoccupazioni che non siano quelle di annunciare fedelmente il Regno di Dio, facciano comprendere inequivocabilmente a chi ascolta il senso più profondo e anche più severo o scomodo della Parola di Dio costringendolo a rivedere le sue idee, le sue teorie, le sue valutazioni, anche ove fossero frutto di anni e anni di studio e di apprendimento accademico, e i suoi stessi atteggiamenti spirituali e pratici soprattutto rispetto ai bisogni dei più poveri, dei più sfortunati, dei più anonimi: la luce evangelica che deve illuminare il mondo non può stare “sopra un monte” né può essere nascosta “sotto il moggio”, il sale evangelico che deve dare sapore alle cose della terra non può essere insipido, perché in tal caso “a null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini”.
Che la Chiesa cattolica abbia allora la prontezza e l’audacia evangelica di denunciare la falsità, la risibilità, l’inverificabilità più assoluta e anche l’evidente contraddittorietà di talune affermazioni dell’attuale presidente del Consiglio, Mario Monti, purtroppo egregiamente coadiuvato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: gli si sente dire infatti che, se non fosse subentrato il governo Monti alla guida dell’Italia, lo spread sarebbe salito a molto più di 1000 punti; che comunque lo spread registrato, prima dell’annuncio dello “scudo” annunciato e varato da Mario Draghi in qualità di presidente della BCE, sarebbe stato “ingiustificato” rispetto ai “fondamentali” o alle “leggi dell’economia”; che, grazie all’attuale politica governativa, sia la situazione economico-finanziaria italiana sia l’euro sarebbero stati salvati dal “baratro” anche se adesso, dopo il gigantesco riordino dei conti pubblici dal governo operato per mezzo di inauditi e vessatori tagli sociali, toccherebbe alle aziende, al mondo imprenditoriale in genere, salvare l’Italia con comportamenti “virtuosi”! Tutte cose in parte pensabili ma assolutamente non dimostrabili e francamente indegne di uno scienziato dell’economia, tutte cose dette pubblicamente con una sicumera non sorretta né da prove, né da riscontri empirici di alcun genere, e basata esclusivamente su congetture tanto dogmatiche quanto arroganti e ingannevoli.
La stessa euforia creatasi in Europa e in Italia dopo il varo dello “scudo antispread” è totalmente ingiustificata e rientra nelle mistificazioni dei grandi banchieri a cui è stoltamente affidata in questo momento storico, da parte delle diverse politiche nazionali, la guida economico-finanziaria del mondo. Perché? Ma perché è evidente che, come si legge su un quotidiano italiano noto per la sua faziosità ma talvolta preciso e puntuale, «il denaro necessario alla BCE per acquistare i titoli di stato sarà rastrellato dalle vostre pensioni, dai vostri salari, dalla vendita delle vostre case. Ottenuto attraverso il vostro licenziamento, l’aumento delle tasse e quello dei prezzi al consumo. Raggranellato privandovi progressivamente di tutti i servizi al cittadino, dalla sanità alla scuola, passando attraverso tutti gli altri» (“Il Giornale”, 7 settembre 2012).
E’ davvero abnorme il fatto che, nella grande stampa e nelle televisioni pubbliche e private del nostro Paese, passino sostanzialmente sotto silenzio l’origine e la provenienza di tecnocrati quali Monti e Draghi (insieme a tanti altri noti esponenti della politica e dell’economia italiane), la loro appartenenza ai clubs economico-finanziari più esclusivi del mondo riconducibili al “Bilderberg Group” e al “Council on Foreign Relations”. Come scriveva sul “New York Times” William Shannon, ambasciatore in Italia del presidente americano Carter e membro del Bilderberg, «i Bilderbergers sono in cerca dell’era del post-nazionalismo: quando non avremo più paesi, ma piuttosto regioni della terra circondate da valori universali. Sarebbe a dire, un’economia globale; un governo mondiale (selezionato piuttosto che eletto) e una religione universale. Per essere sicuri di raggiungere questi obiettivi, i Bilderbergers si concentrano su di un “approccio maggiormente tecnico” e su di una minore consapevolezza da parte del pubblico in generale».
Il giornalista spagnolo Daniel Estulin, autore di un libro molto informato e intitolato “The true story of the Bilderberg Group”, ha scritto che «le idee e la linea politica che vengono fuori dagli incontri annuali del Gruppo Bilderberg sono poi usate per creare le notizie di cui si occuperanno le maggiori riviste e i maggiori gruppi editoriali del mondo. Lo scopo è quello di dare alle opinioni prevalenti dei Bilderbergers una certa attrattiva per poterle poi trasformare in politiche attuabili e di far pressione sui capi di stato mondiali per sottometterli alle “esigenze dei padroni del mondo”. La cosiddetta “stampa libera mondiale” è alla completa mercè del gruppo e dissemina propaganda da esso concordata».
Quanto al “Council on Foreign Relations”, sorto nel 1921, pochi sanno che anche questo selettivo e potentissimo organismo, di cui oggi fanno parte molti capi di Stato e personalità dell’economia e della cultura di tutti i paesi del mondo, muove i fili di un disegno mondiale (d’onde l’ideologia mondialista) che da poco meno di 90 anni decide le sorti, l’evoluzione e gli eventi del nostro pianeta e che è puntualmente all’origine di tutte le crisi economiche o politiche e alla base di ogni dissesto nazionale. Il disegno prevede che il mondo debba essere controllato dall’alto ovvero dalle posizioni più alte dei vertici economico-finanziari internazionali e che la volontà democratica dei popoli debba essere quanto più possibile limitata o contenuta.
Oggi Mario Draghi, presidente della BCE, continua ad esser membro anche del cosiddetto “Gruppo dei Trenta” (G30), un organismo internazionale di finanzieri leaders e accademici finalizzato ad approfondire la comprensione delle questioni economiche e finanziarie e ad esaminare le conseguenze delle decisioni prese nei settori pubblici e privati correlati a tali problematiche. Esso è composto di trenta membri e comprende sia i titolari delle principali banche private e banche centrali, sia esponenti particolarmente influenti del mondo accademico e delle istituzioni internazionali. Per questo motivo, alcuni mesi or sono Draghi ha dovuto subire una dura contestazione (di cui ancora nessuno parla) in sede europea per conflitto di interessi, essendo egli infatti, tra l’altro, uno dei principali proprietari della Banca d’Italia che, diversamente da quel che di solito si pensa, non è una banca pubblica ma privata.
Ora, che il destino dei popoli sia e debba rimanere nelle mani di questi lobbisti e di questi potenti organismi decisionali è ciò che può essere auspicato solo da masse popolari inconsapevoli e da gente sprovveduta. Ma almeno la Chiesa di Cristo non può permettersi né di essere inconsapevole né tanto meno di essere sprovveduta e di venire a patti con certi malefici poteri occulti presenti in ogni angolo della terra, perché essa non potrà continuare ad evangelizzare il mondo e non potrà esercitare efficacemente la sua opera di conversione a Cristo se non sarà capace di individuare e contrastare per tempo, con coraggio evangelico e spirito realmente combattivo, le forze sataniche che affliggono non solo i singoli nel loro privato ma interi popoli nella loro vita pubblica.