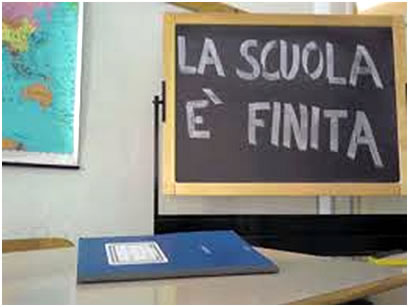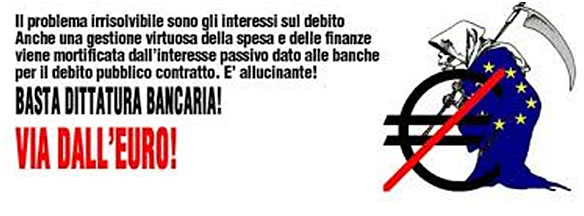Per monsignor Romero il capitalismo, non questo o quel capitalismo, non questa o quella forma di capitalismo, ma il capitalismo tout court che viene naturalmente manifestandosi ed attuandosi in forme e modi differenti nelle diverse aree del pianeta, era una controreligione assoluta, una mentalità ateistica particolarmente pericolosa per la Chiesa cattolica perché facilmente e subdolamente suscettibile di infiltrarsi nella sua stessa coscienza religiosa chiamata a discernere e ad operare in un mondo per l’appunto capitalistico in cui troppo spesso di fatto «i beni materiali si erigono a idoli e sostituiscono Dio». Noi viviamo in un mondo in cui realmente il denaro, come diagnosticava e profetizzava Marx, è diventato cosí onnipotente da eguagliare l’onnipotenza divina: e questo spiega, almeno in parte, perché troppo spesso negli stessi cattolici l’amore del denaro tenda a soverchiare nettamente l’amore verso Dio.
Il vero nocciolo della crisi economica, della crisi etica e culturale contemporanea è proprio qui: nel ritenere che, pur essendo necessarie delle profonde riforme del sistema capitalistico, quest’ultimo sia tuttavia insuperabile ed eterno. Non si riflette più abbastanza sulle parole di Cristo: «cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Cioè: in questo nostro mondo non c’è nulla di eterno, tranne che le “mie” ovvero le sue parole, che sono parole di giustizia, di eguaglianza, di libertà, di invito alla condivisione personale e comunitaria delle pene e delle gioie della vita e alla comunione delle necessità e dei beni materiali e spirituali. Il sistema capitalistico è un prodotto storico e, come tutte le cose della storia, è destinato a passare e a trasformarsi in altro. E’ molto grave che, dinanzi ad una crisi economica e finanziaria cosí profonda ed estesa che incombe sempre più minacciosa sul presente e sul futuro del mondo occidentale ed europeo, si continui a pensare che le cose possano essere ancora rimesse in gioco, corrette, raddrizzate, attraverso semplici inversioni di rotta rispetto alle politiche economiche precedenti, ai privilegi delle cosiddette “caste” e alle colpe presunte o reali della moneta unica, e non piuttosto attraverso una radicale messa in discussione della stessa economia capitalistica sempre più staccata dal lavoro da cui dovrebbe originarsi e trarre la sua naturale alimentazione e sempre più asservita ad un potere finanziario chiuso ed autoreferente che non può non alterarne e non peggiorarne la naturale dinamica.
Qui non si tratta più di distinguere tra un «capitalismo sfrenato» e un «capitalismo moderato o temperato», perché molteplici sono le varianti del capitalismo ma tutte, a seconda delle circostanze e delle epoche storiche, ugualmente e cinicamente funzionali allo sfruttamento della forza lavoro e al perseguimento di un profitto illimitato attraverso un sistematico disconoscimento di vincoli e valori morali. Né, realisticamente, si può continuare a ripetere che l’economia capitalistica senza regole morali produca solo disastri, perché l’economia capitalistica, in quanto costitutivamente fondata sul duplice meccanismo dell’indiscriminata produzione di merce e di una distribuzione necessariamente e costantemente diseguale della ricchezza prodotta, e in quanto non più condizionata e inibita dalla presenza di forme statuali particolarmente agguerrite di comunismo, è intrinsecamente votata a misconoscere ogni genere di vincoli morali che ne frenerebbero inevitabilmente lo sviluppo.
Zygmunt Bauman (Capitalismo parassitario, Laterza 2009), parlando di un “capitalismo parassitario”, ha ben evidenziato come, per precisi motivi di evoluzione storica, gli unici “ospiti” attuali di cui il capitalismo può nutrirsi siano «gli stessi cittadini degli Stati ad economia capitalistica», i quali vengono sfruttati attraverso il loro assoggettamento al pagamento di interessi sempre più arbitrariamente alti sul debito contratto con banche e istituti finanziari, e come le politiche degli Stati capitalisti “democratici” o “dittatoriali” (come la Cina) vengano costruite e condotte nell’interesse e non contro l’interesse dei mercati. Se un tempo gli Stati promuovevano e proteggevano l’accumulazione di capitale attraverso lo sfruttamento della manodopera operaia, oggi assolvono questa stessa funzione attraverso lo “sfruttamento dei consumatori”. Hai contratto debiti, hai chiesto crediti? Bene, adesso paghi alle mie condizioni, con il tasso di interesse che stabilisco io! Questa è la sostanza del problema. Ma, allora, se questo è il prezzo da pagare, perché continuare ad indebitarsi? Perché continuare a chiedere credito e rifinanziamento del debito stesso? E perché non ribellarsi con opportuna sagacia agli istituti finanziari internazionali che impongono agli Stati come l’Italia di pagare persino interessi sugli interessi ordinari relativi ai debiti contratti, allo stesso modo di come istintivamente e moralmente si ritiene generalmente giusto e doveroso negli Stati civili ribellarsi alle criminali ingiunzioni di mafiosi e usurai?
Come può l’Occidente cristiano consegnarsi mani e piedi, corpo e anima, a quei lupi famelici che sono chiamati mercati e che tendono a far strage di tutto, oltre ogni più elementare considerazione di ordine umano e morale, e a divorare tutto pur di ingrassare se stessi? Come possono i credenti in Cristo, e perciò credenti in un Dio che tutto restituisce alla vita, continuare a favorire la crescita a dismisura di questi mostruosi leviatani politico-finanziari che consegnano tutto alla morte e condannano tutti, o meglio tutti coloro che vivono o si sforzano di vivere di onesto lavoro, ad una condizione di schiavitù? Come possono cristiani e cattolici, battezzati in spirito e verità, continuare ad accettare un sistema economico e sociale che incita all’egoismo, che spinge a dilatare le esigenze consumistiche, a moltiplicare esigenze narcisistiche e irrazionali di competitività e di ricchezza indefinita? Non ha forse ragione il teologo Carlo Molari di affermare senza ipocrisie di sorta che «l’attuale sistema capitalistico è per principio incompatibile con l’annuncio cristiano»?
Si dirà che non si può creare ricchezza senza capitale e che, dove d’altra parte c’è il capitale, dev’esserci realisticamente il capitalismo e non un capitalismo che può anche essere riformato e più temperato ma il capitalismo nell’intera gamma delle sue possibili forze espropriatrici. O non c’è accumulazione continua e indiscriminata di ricchezza e siamo in una società chiusa, arcaica, immobile, preindustriale o improduttivamente postindustriale e incapace di sviluppo, o c’è il capitale e restiamo dentro il capitalismo con tutti i benefici ma anche e soprattutto con tutte le negatività sempre più distruttive che esso inevitabilmente comporta. Tertium non datur, potrebbe dirsi.
Se però cambiano i modi e i tempi della produzione, e quindi l’organizzazione complessiva del mondo del lavoro e i suoi livelli di produttività, le forme stesse dello sviluppo, della crescita e del profitto, nel senso che esse non siano più concepite e perseguite in termini assoluti e illimitati ma in termini di sostenibilità relativa alla situazione e alle necessità specifiche ed oggettive delle diverse regioni del pianeta e dello stesso occidente europeo, noi possiamo evitare il rischio della staticità o dell’immobilismo economico senza tuttavia rimanere imbrigliati nel quadro dello sfruttamento capitalistico, e al tempo stesso ci facciamo promotori di una prosperità economica reale ma non ossessiva e soprattutto non vantaggiosa solo per alcuni bensí volta a non costringere nessuno, e in particolare i meno abbienti, ad indebitarsi e a chiedere prestiti forzosi e letali o a vivere in condizioni assolutamente miserevoli.
Non si tratterebbe quindi di aggiustare il sistema con qualche cambiamento o riforma di facciata o immettendovi un po’ di etica, di salvarlo ancora una volta per salvarlo sempre e per mantenerne sostanzialmente inalterati assetti e meccanismi di potere, ma di superarlo radicalmente attraverso una serie di coraggiose ed incisive trasformazioni strutturali, ovvero anche di natura legislativo-normativa e giuridico-finanziaria, di cui naturalmente dovrebbe imparare a farsi carico la politica, sebbene oggi essa sia ancora esercitata, mi perdonino se esagero, da soggetti generalmente impreparati, codardi e inaffidabili.
A ben vedere, una siffatta prospettiva non contribuisce a ridisegnare il nostro mondo economico e sociale? Non può inaugurare una nuova stagione della storia umana ed introdurre in un’organizzazione sociale non più capitalista perché organicamente fondata più su vincoli comunitari di tipo morale che non su vincoli sociali di tipo meramente contrattuale? Non sarebbe il caso che, in presenza di una sinistra politica incredibilmente assuefatta all’idea che il mondo debba vivere e svilupparsi dentro il capitale (F. Rampini, Alla mia sinistra, Mondadori 2011), anche i cattolici e anzi i cattolici per primi, nel nome della loro stessa fede, cercassero di rovesciare tale prospettiva per costringere il capitale a stare nel mondo, a calarsi cioè nelle differenze della storia e della politica, nei bisogni reali e non artificiali dei popoli e delle singole comunità nazionali?
Urgono regole radicalmente nuove, leggi radicalmente alternative a quelle che garantiscono gli attuali equilibri economico-finanziari nel mondo e in Italia. Forse in parte è vero che «coloro che credono che la democrazia liberale e il libero mercato possano essere difesi con la sola forza delle leggi e delle regole, senza un senso interiorizzato del dovere e della morale, si sbagliano tragicamente», ma è certo che, a parte il fatto che quello della fede in una democrazia liberale è un cliché ormai logoro e sempre più privo di mordente tanto quanto lo sarebbe quello di una fede in una democrazia socialista di già noto stampo culturale, regole e leggi esemplarmente nuove e severe sono più che mai necessarie e improcrastinabili, anche se esse presuppongono un “senso interiorizzato del dovere e della morale e, aggiungerei, della stessa fede per chi ce l’ha o ritenga di averla (Jonathan Sacks, rabbino capo del Regno Unito, L’anima perduta dell’Europa. Risanare l’Europa è molto più che stabilizzare l’euro, lezione del 13 gennaio 2012 presso la Pontificia Università Gregoriana).
I cattolici sono oggi chiamati a battersi non più per rattoppare un sistema ormai logoro e irreversibilmente corrotto, non più per rinviare ancora una volta un fallimento delle finanze pubbliche destinato comunque a restare in agguato contro i popoli e le persone più indifese, ma per invertire radicalmente la rotta dell’economia nazionale e mondiale attraverso prese di posizione e misure politiche drastiche e limpide ad un tempo per mezzo delle quali i cosiddetti “poteri forti”, i mercati, le famigerate agenzie di rating, i vari organismi della finanza internazionale, gli stessi istituti di studi economici e finanziari esclusivamente riservati a riconosciute eminenti personalità del mondo politico, scientifico e culturale di ogni parte del pianeta, siano costretti a mettersi l’anima in pace, a rivedere profondamente le proprie dottrine, le proprie teorie, i propri calcoli, i propri criteri di previsione e programmazione politico-economiche, e quindi anche a rinunciare alle proprie ambizioni circa la creazione di una governance sovranazionale, alle proprie manie di globalizzazione indiscriminata persino degli stili di vita, delle sensibilità e dei gusti, delle tradizioni e delle peculiarità di ciascun popolo e di ciascun individuo, delle specificità antropologiche di ogni gruppo umano, nel quadro di una progressiva e presunta quanto indifferenziata unificazione razionale dei vari sistemi giuridico-legislativi, economico-finanziari, culturali e religiosi.
I cattolici dovranno resistere all’idea che l’unità del genere umano su valori e scelte di vita, specie se manifestamente e irragionevolmente contrari agli interessi collettivi e personali di larga parte delle masse popolari, possa essere imposta dall’alto e da parte di un ristretto gruppo di persone, i cosiddetti “illuminati”, che non esprimono molto altro, con i loro progetti di risanamento tanto sofisticati quanto spesso illusori e ingannevoli, al di là degli interessi forti di potenti caste finanziarie internazionali. Noi cattolici siamo tenuti ad aprire gli occhi evangelicamente, con il candore dello spirito e la circospetta ed intuitiva intelligenza della mente, sui processi in atto che, di riforma in riforma, di taglio in taglio, di privatizzazione in privatizzazione, puntano ad una espropriazione quanto più possibile avanzata e generalizzata della ricchezza pubblica, sia in senso materiale che in senso immateriale, di tutti i cittadini del mondo. Dobbiamo renderci conto e mostrare chiaramente che il re è sempre più nudo, che di sacrificio in sacrificio la gente muore o vive in preda alla disperazione, che è semplicemente vergognoso ritenere di poter tutto cambiare e riformare (riforma del sistema pensionistico, della pubblica amministrazione, del mercato del lavoro, ecc.) tranne che i mercati stessi e i mercanti non certo probi e disinteressati che li gestiscono e li manovrano.
C’è un altro aspetto dell’analisi che è necessario fare. Tutte quelle imposte dirette ed indirette, tutti quei tributi locali e nazionali, tutte quelle tasse governative regolarmente versate, tutte quelle azioni volte spesso con successo contro grandi evasori fiscali e contro immensi patrimoni più o meno legali, non sono mai sufficienti a tenere in equilibrio il bilancio dello Stato, ad onorare l’impegno di pagare i debiti nazionali e ad assicurare servizi pubblici decenti ai cittadini? Fiumi torrentizi di denaro che riempiono sistematicamente le casse dello Stato sino a farle straboccare, non bastano mai a risanare debiti, a rimettere le cose a posto, ad assicurare alle fasce sociali meno protette condizioni di vita quanto meno accettabili? Possibile che lo Stato abbia sempre bisogno di manovre economiche che, anziché favorire l’emancipazione qualitativa della vita della generalità dei suoi cittadini, sottopongano questi ultimi ad interminabili e dolorose vessazioni? Cosa bisogna aspettare per risanare lo Stato: un depauperamento progressivo della società? E alla fine cosa sarà rimasto di tanto appetibile? Uno Stato risanato, forse; ma per quanto tempo, ma per chi, a vantaggio di chi e a quale prezzo? Che differenza c’è, a parte l’orribile immagine di cadaveri disseminati per le strade, tra le rovine di una guerra e le rovine ineluttabili di queste “civilissime” e truffaldine manovre governative e statuali?
Dare a Cesare quel che è di Cesare non significa affermazione astratta del rispetto per qualunque autorità di governo e per qualsiasi obbligo di legge previsto da un ordinamento statuale; significa affermazione consapevole e responsabile del rispetto che si deve allo Stato e ai suoi ordinamenti nei limiti in cui essi restino compatibili con l’obbligo di obbedire a Dio e di rispettare i suoi comandamenti, tra cui quello di non rubare, di non espropriare in modo non già illegale ma illecito, di non privare nessuno della propria dignità personale, di non comminare pene per gli innocenti, di non creare disperazione nella vita dei popoli e delle persone. Per il cristiano e per il cattolico, Cesare non può fare quello che vuole, specialmente se quello che vuole è assecondare sempre e comunque i mercati e i mercanti, soddisfare impunemente le brame dei ricchi e dei potenti, veicolando propagandisticamente ipocriti e irresponsabili messaggi di risanamento e civilizzazione.
Cesare è legittimato da Dio a fare uso del potere, della forza, della coercizione, per far rispettare l’ordine sociale, le leggi, le norme della convivenza, e certo anche il possesso privato di beni, ma solo nei limiti in cui egli non usi la frode, l’inganno, l’iniquità deliberata come strumenti di potere e di governo. Se evangelicamente occorre dare a Dio quel che è di Dio, il cristiano sa di non poter indulgere a prassi governative di qualsivoglia natura, di non potersi e non doversi inginocchiare di fronte ad una violenza beluina sebbene incruenta di Stato, ma di doversi opporre per cambiare quanto più pacificamente possibile quel Cesare che sta infrangendo le regole più elementari della vita associata e della vita comune voluta da Dio, pur sempre disposto a sacrificarsi per il bene comune senza far uso di violenza.
La storia cambia gli uomini non meno di quanto gli uomini siano chiamati a cambiare la storia: la storia, la politica, l’economia, la vita stessa di ogni comunità. Ma se la storia cambia gli uomini più di quanto gli uomini siano capaci di cambiare la storia con una sana capacità di discernimento, l’umanità si condanna ad essere oggetto passivo di trasformazioni impersonali e oppressive. Chi più del cristiano-cattolico può e deve mostrarsi pronto ad impedire che la vita sia asservita all’economia che dovrebbe esserne invece un semplice strumento per quanto prezioso? Chi più di lui è tenuto a perseguire la giustizia di Dio piuttosto che la giustizia degli uomini quando questa nasce dalla menzogna, dalla falsità, dall’inganno più o meno premeditato?
E non è manifestamente falso e ingannevole sostenere che, poiché c’è una crisi economica globale che mette a repentaglio la tenuta economico-finanziaria di molti paesi occidentali fra cui l’Italia, allora non si può fare a meno di imporre gravi “sacrifici” alle masse popolari, e in particolare ai ceti più poveri o meno abbienti? Non è ipocrita sostenere che i sacrifici devono essere fatti da tutti quando appare del tutto evidente che il reddito di molti cittadini, già abbondantemente tartassati da imposte tasse e tributi, è nei casi migliori appena sufficiente ad assicurarne la sopravvivenza? E’ mai possibile che non si possa e voglia capire che, specialmente in certe congiunture economico-sociali, i poveri e i disagiati devono essere totalmente risparmiati dalle politiche fiscali e che sia assolutamente giusto ed equo che l’intero peso fiscale di determinati provvedimenti governativi ricada unicamente e sia pure proporzionalmente sulle spalle di benestanti e “ricchi”?
Un reddito personale di 60.000 euri netti annuali è o non è il reddito di una persona benestante? E chi percepisce più di 100.000 euri all’anno si può o non si può definire ricco? Bene, è cosí complicato accertare il numero di questi “fortunati” in un paese come l’Italia? O si continuerà ad argomentare che non si debbano troppo infastidire i ricchi perché ne andrebbe della loro volontà produttiva e di investimento, della loro capacità di creare posti di lavoro e di contribuire allo sviluppo e alla ripresa economica di tutta la nazione? Come dire: attenti a non toccare troppo i ricchi perché altrimenti si rischia di condannare la classe imprenditoriale a una sorta di demotivazione produttiva che determinerebbe a sua volta una notevole riduzione della produttività e della competitività nazionali sul piano internazionale.
Ma è morale tutto questo? I cattolici possono far finta, e per quanto tempo ancora, di credere veramente che tutto ciò sia sensato, sia vero, sia giusto, sia praticabile e funzionale al bene comune? Io non so se il governo Monti sia davvero, come dice il cardinale Bagnasco, «un esecutivo di buona volontà» che si starebbe seriamente sforzando di rimettere a posto le cose e che meriterebbe di essere apertamente coadiuvato da tutte le forze politiche italiane (Relazione introduttiva alla Conferenza Episcopale Italiana, 23-26 gennaio 2012), ma, dato il curriculum vitae del professor Mario Monti, è oggettivamente difficile immaginare che egli, di punto in bianco, si renda completamente autonomo da quegli “illuminati” e molto discutibili ambienti internazionali di stampo neoliberista e da quel variegato e spesso oscuro mondo economico-finanziario di cui ha sempre fatto parte e continua a far parte, condividendone analisi diagnosi e terapie, e che hanno prodotto e continuano a produrre irresponsabilmente i maggiori disastri dell’economia mondiale e delle diverse economie nazionali, a cominciare da quella italiana.
Dobbiamo sentirci affetti da inguaribile malizia nel ritenere che, ove il risanamento nazionale riesca almeno per i prossimi dodici-diciotto mesi (giusto il tempo di restare e di lasciare il governo), tale risanamento sia eventualmente solo e proprio quello voluto nell’immediato dalle multinazionali dell’alta finanza internazionale, e che di successive ipotetiche crisi finanziarie egli potrebbe disinvoltamente lavarsi le mani? Non che ci si voglia fare, ci mancherebbe altro, difensori dello status quo: ma qui il problema è che i cambiamenti proposti dagli “esperti” sembrano tutti oggettivamente orientati ad impoverire la condizione economica dei popoli, a ridurre notevolmente il tasso democratico e la qualità della nostra vita civile. Ecco perché, in questo frangente, mi pare più condivisibile la preoccupazione espressa dalla Chiesa per bocca di un altro suo eminente esponente, ovvero monsignor Bregantini, responsabile della Commissione Cei per i problemi sociali e il lavoro, il quale non si è affatto compiaciuto della manovra del governo Monti e ha dichiarato che, pur essendo “necessaria”, essa «poteva essere più equa», per cui si «sono fatti dei passi…che però potevano essere più equanimi» e più decisi in relazione «ai redditi alti» (dichiarazione del 5 dicembre 2011).
Non mi auguro affatto di avere ragione. Spero sinceramente che i dubbi qui espressi possano essere fugati da fatti incontrovertibili che dimostrino la giustezza e l’efficacia delle misure varate dal governo Monti e che questi non sia un volgare imbonitore ma un vero servitore dello Stato, della società e della Chiesa. Ma, francamente, non sussistono per ora elementi che consentano ai cattolici di pensare che il tentativo di Monti sia uno di quei tentativi attraverso cui si fa più vicino il giorno in cui «Cristo sia il cuore del mondo». E allora cosa dobbiamo fare, cosa resta da fare?
Innanzitutto, pur riconoscendo ovviamente che «evadere le tasse è peccato» (Relazione introduttiva di Bagnasco alla Cei, cit.), è assolutamente necessario precisare, e tenerne ben conto sia in sede morale sia in sede politica, che altro è il peccato del ricco che evade le tasse e altro è il peccato di chi le evade in quanto versi in uno stato di indigenza o di grave precarietà economico-finanziaria; in secondo luogo, bisogna impegnarsi a fondo perché i princípi e i valori della nostra carta costituzionale non vengano cancellati o sepolti da un pragmatismo politico orientato a distruggere le più avanzate conquiste di civiltà e progresso ottenute dai popoli europei e in particolare dall’Italia relativamente a stato sociale, a diritti e tutele a beneficio del mondo del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici, oppure bisognerà impegnarsi per ripristinare il più presto possibile quei princípi e quei valori ove fossero stati già parzialmente vanificati; in terzo luogo, si dovrà essere capaci di elaborare una nuova strategia politica con la quale sia possibile non più accondiscendere a tutti gli umori dei mercati e alle relative istanze dei potentati finanziari del mondo ma metterne in discussione e persino fuori legge metodiche di misurazione dei debiti sovrani, aspettative e pretese, ove esse dovessero apparire manifestamente illegittime e contrarie al comune senso civico e morale del genere umano: una delle richieste più odiose che in questo periodo si sente fare, ovvero la cessione parziale della sovranità nazionale in materia fiscale da parte di paesi particolarmente indebitati, dovrebbe essere respinta al mittente come criminale ed infame.
Inoltre, sarà necessario sventare per tempo il pericolo di un radicarsi nella coscienza comune di idee che hanno tutta l’apparenza delle banalità e delle mistificazioni. Fa sorridere ad esempio Monti quando, per giustificare la reintroduzione dell’ICI-IMU, afferma che la non tassazione della prima casa è una stonatura esclusivamente italiana e che era necessario eliminare tale anomalia per mettersi finalmente sul piano degli altri stati europei, quasi che tutto ciò che vige in Europa dovesse essere preso per oro colato, mentre d’altra parte l’Italia sarebbe in perfetta media europea per ciò che si riferisce agli stipendi dei parlamentari e degli europarlamentari europei.
Come mai, peraltro, non si ritenga di aumentare gli stipendi degli operai, dei dipendenti del pubblico impiego, degli insegnanti della scuola primaria e secondaria o degli ospedalieri in Italia, visto che essi sono largamente inferiori a quelli dei colleghi europei, resta un mistero che genera profonda tristezza in chi vorrebbe ma non può riporre la sua fiducia nel cosiddetto “governo tecnico”. E preoccupazioni non meno gravi non possono non essere ingenerate da parte di chi propagandisticamente e solennemente dichiara, ma qui anche la Chiesa non deve peccare di ingenuità, che la civiltà di una nazione si misura dalla modernità e funzionalità delle carceri.
Ma come: voi dite che non ci sono soldi, che dovete riformare oggi le pensioni riservandovi magari di decurtarle insieme agli stipendi domani, che dovete imporre tasse a destra e a manca per far fronte al debito contratto con gli investitori stranieri, e poi, proprio mentre si abbassa spaventosamente il tenore di vita di larga parte della popolazione e la sua possibilità di soddisfare decentemente bisogni primari, proprio mentre si razionalizza la spesa pubblica chiudendo e accorpando scuole e ospedali e lasciando in uno stato fatiscente numerosi luoghi dell’edilizia scolastica e beni del patrimonio artistico-culturale, vorreste ricominciare la ricostruzione “europeista” del nostro paese dalle carceri, investendo denaro pubblico nell’edilizia e nella tecnologia carceraria? Ma vogliamo provare a ragionare seriamente prima di parlare o vi deve essere consentito di dire qualunque sciocchezza solo perché “tecnici”?
Ma, in questo momento, i cattolici, e si spera a breve un nuovo e coriaceo partito cattolico, né classista né interclassista ma semplicemente dotato di un forte senso della giustizia sociale e della giustizia tout court, e quindi per niente indulgente verso forme sofisticate o volgari di relativismo etico, devono porre al centro della loro agenda politica le istanze e le misure da far valere nei confronti di quei “mercati” arroganti e omnipervasivi che pretendono in modo sempre più impudente di avocare a sé la sovranità e dunque il governo della vita di milioni e milioni di persone, quella sovranità e quel governo che le costituzioni degli stati democratici assegnano ai popoli.
Certo, perché ormai è abbastanza chiaro che dietro questi “mercati” c’è la finanza internazionale che è la forma più compiuta, astratta e “delocalizzata” del capitale, che a sua volta è costituito e rappresentato da enormi patrimoni privati (hedge fund, private equity o fondi di investimento) che in un periodo di tempo relativamente breve sono cresciuti in virtù di un gigantesco trasferimento di ricchezze (circa il 10 per cento del PIL di quasi tutti i paesi; che per un salario può corrispondere al 40 o al 50 per cento del potere d’acquisto) dai redditi di lavoro ai redditi da capitale. Dietro i “mercati” ci sono anche le grandi banche e le grandi multinazionali, e soprattutto assicurazioni e fondi pensioni, ben adusi alle più svariate e sofisticate operazioni di investimento e di speculazione che presentano altissimi margini di rischio e di guadagno e le cui eventuali perdite alla fine ricadono sui consumatori e sul loro portafoglio.
Per imparare a intercettare, a smascherare e a combattere gli scaltri mercanti apparentemente e momentaneamente anonimi dei mercati e di questi mercati, non basta certo il ripudio della politica e il ricorso istintivo all’antipolitica. Con la Chiesa bisogna ribadire invece che «la politica è assolutamente necessaria, e deve mettersi in grado di regolare la finanza perché sia a servizio del bene generale e non della speculazione. Non è possibile vivere fluttuando ogni giorno nella stretta di mani invisibili e ferree, voluttuose di spadroneggiare sul mondo. Sembra, invece, che i grandi della terra non riescano ad imbrigliare il fenomeno speculativo; che giochino continuamente di rimessa, sperando ogni volta di scamparla alla meno peggio, ma è un’illusione: prima o poi arriva il proprio turno, e ci si trova in ginocchio come davanti ad un moderno moloch di non decifrabile direzione. Il dubbio è che si voglia proprio dimostrare ormai l’incompetenza dell’autorità politica rispetto ai processi economici, come se una tecnocrazia transnazionale anonima dovesse prevalere sulle forme della democrazia fino a qui conosciuta, e dove la sovranità dei cittadini è ormai usurpata dall’imperiosità del mercato» (Relazione Cei del 23 gennaio 2012, cit.).
Il che però implica che almeno i cattolici italiani si mettano totalmente a difesa della democrazia repubblicana e della inalienabile sovranità popolare da essa sancita pensando a come rifondare la politica per renderla più idonea a rappresentare e a tutelare coerentemente i legittimi interessi del popolo e della stessa umanità attraverso un’adeguata accentuazione dell’istanza di socializzazione e di comunione dei beni rispetto a quella, pure legittima e socialmente necessaria ma non dotata di valore assoluto né gerarchicamente superiore alla prima, di privatizzazione dei beni medesimi.
Dovremo altresí imparare a neutralizzare i veementi e sistematici attacchi dei mercati di questo tempo con misure appropriate e persino insubordinate rispetto alle implacabili logiche mercantili della finanza europea e mondiale, anche se suscettibili di arrecare ulteriori sofferenze alle popolazioni e ai cittadini economicamente più deboli. Ulteriori sofferenze, forse, in quanto rifiutarsi di continuare a pagare i debiti usurai implica un default dalle conseguenze probabilmente pesanti (ma non necessariamente pesanti), ma questa volta sofferenze all’interno di un processo di liberazione e di affrancamento definitivo da un’idolatria monetaria e non solo monetaria sempre più vorace, e non più nel quadro di un graduale e irreversibile asservimento dei popoli e del nostro popolo all’onnipotenza del dio denaro.
Dio, che non abbandona mai i figli che lo invocano con cuore sincero, ha liberato una volta il suo popolo dalla schiavitù egiziana; Dio libererà il suo popolo anche dall’attuale schiavitù finanziaria prima di liberarlo definitivamente dal peccato, dal male e dalla morte.
Post Views:
2.152